Ed eccoci al secondo appuntamento. Oggi condivido con voi tre album molto diversi tra loro. In comune c’è la ricerca, sia che si tratti di MPB, Musica Popular Brasileira, o di un rock alternativo o di un jazz che ha il compito di comunicare, raggiungere il maggior numero di persone possibile, e per fare ciò, parla e fonde linguaggi attuali, come l’hip hop e un rinato spoken word. Partiamo dunque!

1 – Bachianinha: Toquinho e Yamandu Costa (Live at Rio Montreux Jazz Festival) – Toquinho e Yamandu Costa
Due giganti della musica brasiliana e della chitarra. Due generazioni diverse, due origini diverse: Toquinho, 74 anni, è nato e cresciuto a São Paulo, Yamandu Costa, 41 anni, viene da Passo Fundo, città del Rio Grande do Sul. Il primo erede di un modo di suonare che vede in Vinicius de Moraes, con cui ha collaborato a lungo, e la bossa nova il suo naturale elemento. Il secondo viene dallo Choro, dalle bachianinhas, musiche popolari ispirate a Bach, che suo padre suonava, e da un tipo di musica “di frontiera”, gaucho, appunto, dove Brasile Argentina, Uruguay e Paraguay si fondono anche nelle note. Il live è stato registrato lo scorso anno, senza pubblico a Rio, causa pandemia. Il disco è uscito il 21 maggio. Se vi piace il suono della chitarra classica e della chitarra a sette corde, di cui Yamandu è un virtuoso, lo ascolterete tutto d’un fiato. Il repertorio scelto dai due, che per la prima volta incidono insieme, anche se si conoscono da molti anni, si basa sulla musica d’autore brasiliana. Sto parlando di Dorival Caymmi, per i musicisti del gigante sudamericano, un mito intoccabile: un brano che in realtà ne include due, rivisti il minimo possibile da Toquinho, apre l’album O Bem do Mar/ Saudade da Bahia, per proseguire con un altro classico, Asa Branca di Luiz Gonzaga sempre con Toquinho solo sul palco. Yamandu risponde con A Legrand, suo pezzo originale dedicato al musicista francese Michel Legrand. Insieme deliziano com Apelo, storico brano di Baden Powell. Bossa e choro, come nella Bachianinha n°1 di Paulinho Nogueira. Insomma, credo l’abbiate capito, se volete immergervi nel Brasile d’altri tempi questo è un disco che fa per voi. Tecnica, pathos, amore, confronto generazionale, gli ingredienti ci sono tutti. Ve lo consiglio!

2 – Bright Green Field – Squid
Cambiamo registro, totalmente. Dopo un paio di Ep e una serie di singoli, gli Squid, band di Brighton, sono usciti con il loro primo album il 7 maggio scorso. Come inquadrarli? Post punk? No, troppo semplice. Piuttosto musicisti creativi che fanno delle contaminazioni un loro punto di riferimento e forza. Se ascoltate Narrator, vi trovate il sapore dei Talking Heads, mentre in G.S.K. delle note acide di funk si fondono bene con la voce di Ollie Judge che, per inciso, trovo molto simile al primo David Byrne, mentre le chitarre diventano potenti, con inserimenti di tastiere post prog. 2010 ha un attacco morbido alla Steve Hackett dei Genesis e prosegue in maniera sempre più decisa, per arrivare a un metal bello denso. Piacciono? Li trovo interessanti, una musica che potremmo sicuramente inserire nella grande casa del Rock, finalmente diversa, un bell’esercizio di stile che fa ben sperare. Va ascoltato più volte per coglierne le diverse sfumature. Non licenziatelo al primo passaggio, fareste un grosso errore…

3 – Black To The Future – Sons Of Kemet
Dietro Sons Of Kemet si nasconde Shabaka Hutchings, un sassofonista e clarinettista londinese che si divide fra tre sue creature, i Sons Of Kemet, appunto, con cui fa un jazz/hip hop, i Comet Is Coming con i quali si diletta nel soul prog, e i Shabaka and the Ancestors, gruppo con cui suona spiritual jazz. Ci sono altri jazzisti che fanno hip hop tramite loro alter ego. Ad esempio, il trombettista americano Leron Thomas che si trasforma in Pan Amsterdam (ve ne ho parlato nell’ottobre dello scorso anno). Torniamo a Black To The Future: Hutchings vuole parlare di memoria collettiva sulla questione razziale, e lo fa attraverso una musica complessa, sempre molto spinta. Suona, ma le note qui sono politica, cerca di unire i vari filoni della diaspora africana, quello americano e quello inglese. Chiede, come nota Hubert Adjei-Kontoh, il critico che ha scritto la recensione del disco per Pitchfork, uno sforzo di tutti, un impegno comune per parlare dell’oppressione e della storia che attanaglia gli africani. La musica segue esattamente questo. I Sons Of Kemet sono in quattro, due fiati e due percussioni, eppure la musica che ascoltate sembra uscita da una superband. La tuba suonata da Theon Cross fa il lavoro del basso, Shabaka Hutchings “canta e ricama” con il sax e il clarinetto, le percussioni di Tom Skinner ed Edward Wakili-Hick pompano richiami e tempo creando un pattern d’alta combustione. In Pick Up Your Burning Cross, per esempio, agli strumenti si aggiungono le voci di Moore Mother, musicista, poetessa, attivista di Philadelphia, e di Angel Bat Dawid, jazzista americana. Come in Hustle, dove il rapper inglese Kojey Radical canta a ripetizione Born from the mud with the hustlе inside me… Si chiude con Black (più cristallino di così!) con l’intervento, in perfetto spoken word, del poeta Joshua Idehen. Un crescendo tragico, duro, un pugno nello stomaco. Qui i primi versi…
Black is tired
Black would like to make a statement
Black is tired
Black’s eyes are vacant
Black’s arms are leaden
Black’s tongue cannot taste shit
Black’s stomach cannot compress death
And black would like to state that black is not a beast of myth
To be slain in a fable
Recounted atop a round table
Surrounded by blue-collared brave men
Black has demands
Black demands baton-proof bones and bullet-resistant skin
Black thinks no person that’s trigger nervous deserves a gun
Much less a badge…
















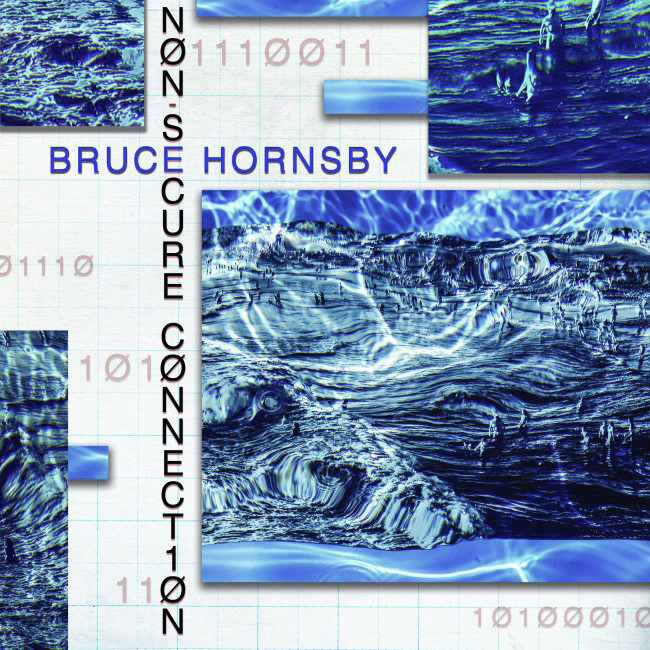
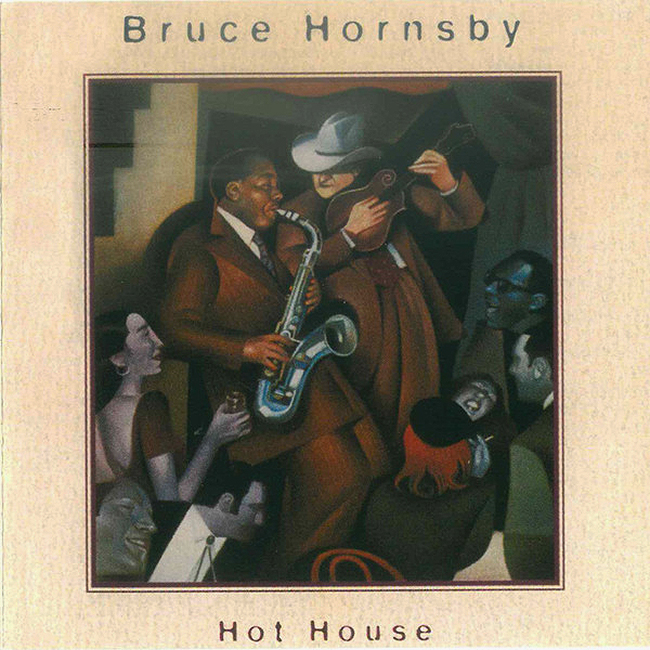











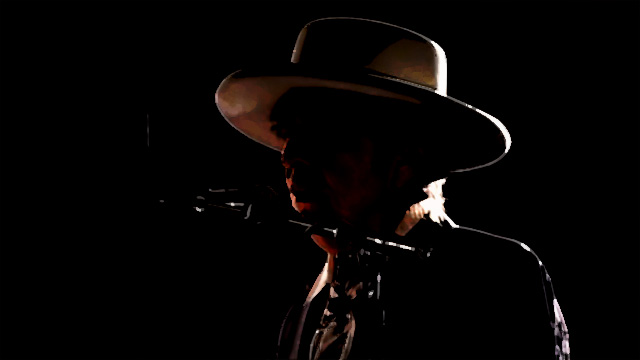

 Concludo dicendovi cosa sto ascoltando ora con grande interesse ijn questi giorni: il jazzista israeliano Avishai Cohen (da non confondere con l’omonimo contrabbassista jazz) con il suo nuovo progetto Big Vicious, album uscito il 20 marzo scorso. Trombettista che esplora tanti generi dal jazz al rock al trip hop. Molto interessante l’interpretazione della beethoveniana Moonlight Sonata. Qui godetevelo in
Concludo dicendovi cosa sto ascoltando ora con grande interesse ijn questi giorni: il jazzista israeliano Avishai Cohen (da non confondere con l’omonimo contrabbassista jazz) con il suo nuovo progetto Big Vicious, album uscito il 20 marzo scorso. Trombettista che esplora tanti generi dal jazz al rock al trip hop. Molto interessante l’interpretazione della beethoveniana Moonlight Sonata. Qui godetevelo in