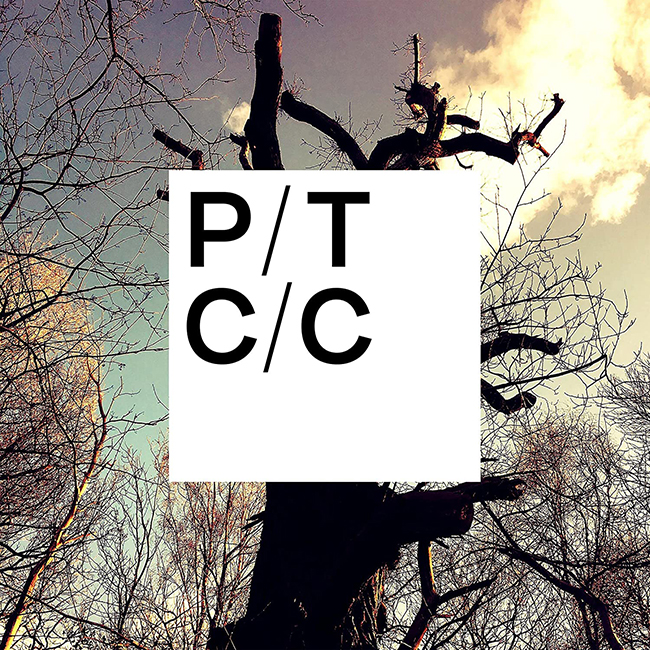Fra le tante uscite di ottobre mi ha colpito un lavoro che, dalla sua pubblicazione, è diventato per me un ascolto quotidiano. Si tratta di Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen, edito dalla Blue Note Records e dato all’ascolto il 14 del mese scorso.
Non sono un amante dei dischi che in qualche modo sfruttano il lavoro di artisti scomparsi. Ma qui, accidenti, siamo davanti a ben altra cosa. Un vero tributo, un omaggio in punta di piedi ma potente, ricco e fedele, dove non prevale l’identità del singolo artista che interpreta ma dell’autore. Che risponde all’immenso nome di Leonard Cohen, uno dei più grandi cantautori che hanno calcato questo pianeta, ammirato, imitato, seguito.
L’idea del disco – come probabilmente avrete già letto – è di Larry Klein, bassista stranoto, vincitore di Grammys, compositore e turnista d’eccellenza (da Bob Dylan a Peter Gabriel, da Herbie Hankock a Joni Mitchell (della quale è stato anche marito), amico di Cohen fin dai primi anni Ottanta. Il quale ha pensato a un parterre di artisti da brivido: Norah Jones, Peter Gabriel, Gregory Porter, Sarah McLachlan, Luciana Souza, James Taylor, Iggy Pop, Mavis Staples, David Gray e Nathaniel Rateliff. Continua a leggere