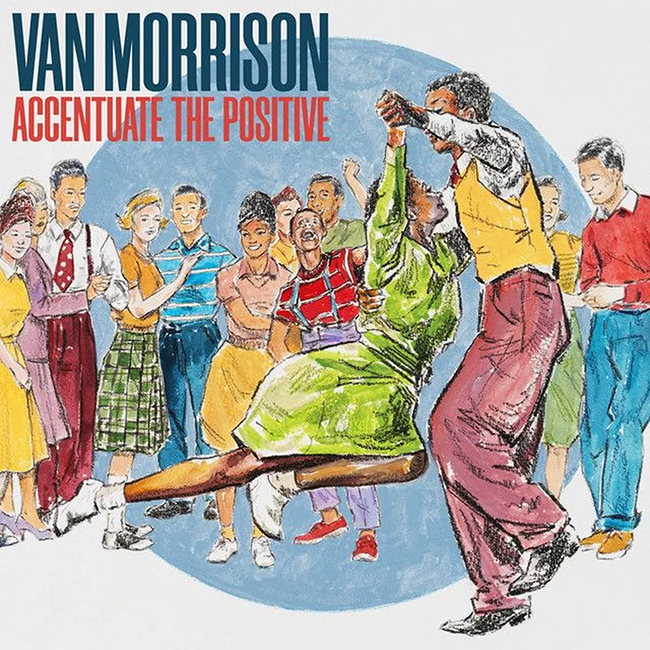Maria Mazzotta – Foto Alessia Rollo
Venerdì 18 luglio a Ronco, una frazione di Ghiffa, provincia di Verbania, che si affaccia sul lago Maggiore, nell’ambito della terza edizione del Festival Musica e Spiritualità, si esibirà Maria Mazzotta con il fisarmonicista Antonino De Luca. La cantante salentina, che da anni lavora sulle musiche popolari, presenta un lavoro che ha avuto molto seguito e credito, Amoreamaro, disco uscito nel 2020.
Un progetto molto particolare, intimo, profondo: l’amore al femminile raccontato in tutti i suoi aspetti, dalla bellezza alla morte, usando ovviamente la musica folk, salentina, napoletana, romana, abruzzese, siciliana. Un concerto perfetto per il concept di Musica e Spiritualità, come spiegano gli organizzatori: «È un boutique festival che invita al raccoglimento, dedicato a quella che ci piace definire “L’arte dell’incontro”, alla valorizzazione delle piazze, degli spazi che tornano, grazie agli appuntamenti in programma, a essere luoghi restituiti alla comunità, alla condivisione, allo scambio di emozioni». Continua a leggere