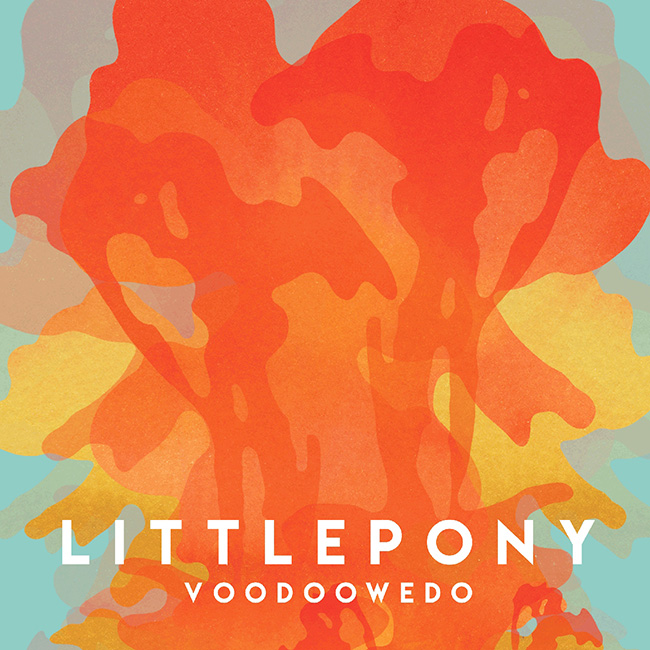Antonio Ribatti – Foto Robert Cifarelli
Sono convinto che la formazione musicale viaggi lungo un doppio binario. Non solo quella, evidente, degli artisti, ma anche, in parallelo, l’altra, degli ascoltatori. Come detto molte volte in questo blog, ribadito dalle interviste a numerosi musicisti, fra tutti il grande Claudio Fasoli, la musica è un linguaggio e, come tale, perché lo si possa capire e “parlare”, bisogna studiarlo. Avere, insomma, un minimo di infarinatura, che nelle Americhe come in altri Paesi europei esiste fin dalle scuole primarie, mentre da noi rimane per lo più sulla carta… Non fraintendetemi: la musica è un piacere, come lo studio d’altronde, ma per gli ascoltatori curiosi e non passivi la voglia di entrare in un brano, coglierne la sua natura, filtrarla ed elaborarla attraverso le proprie emozioni, è una grande soddisfazione.
Perché vi sto parlando di ciò? Questa sera, a Settimo Milanese inizia Parole al Vento (qui programma, orari, indirizzi), quattro appuntamenti scanditi tra aprile e maggio. Il suono disorganizzato è il tema di oggi, incontro e prova aperta con quell’istrione di Ferdinando Faraò, con cui avevo chiacchierato alcune settimane fa a margine di un suo intervento educativo con l’Artchipel Orchestra.
Il 20 aprile è previsto Inseguendo quel suono – Una storia di Ennio Morricone (Alessandro De Rosa, voce narrante, Fausto Beccalossi, fisarmonica, e Claudio Farinone chitarre), mentre il 4 maggio, Batuke – Storia sociale del Samba, a cura di Nené Ribeiro, chitarra e voce, e Kal dos Santos, percussioni e voce, con il laboratorio di percussioni Toc Toc; e, infine, il 18 maggio, Mingussiana: Seven for Mingus, con Tino Tracanna e gli allievi del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.
Quattro incontri dove suono, cultura, condivisione, mondi diversi possono stimolare il pubblico in connessioni sonore impreviste. Ne ho parlato con Antonio Ribatti, ideatore e curatore della manifestazione. Antonio è un architetto di professione, ma anche fotografo, trombettista jazz, con l’Arte nella testa e una enorme creatività usata per coinvolgere con un unico scopo: mostrare la bellezza: di un racconto, un canto, un concerto, un dipinto, un luogo…
Tutti sappiamo quanto abbiamo bisogno di bellezza, soprattutto dopo due anni di pandemia e ora, con una sporca guerra alle porte di casa. La bellezza non è frivola, è piuttosto un’arma potente che, a differenza dei razzi ipersonici, delle bombe a grappolo e della misera cattiveria cecena, non uccide ma salva, aiuta, fa crescere gli individui. Direte che sono un pazzo, ma ci credo fermamente. Al mitra contrapponi un canto, alla ferocia la bellezza di un trio jazz, alla depressione la forza di un’orchestra…

Con il festival AHUM da oltre vent’anni cerchi di portare bellezza sostenendo che l’Arte è il frutto di una interconnessione continua tra musica, pittura, scultura, letteratura, poesia, teatro, danza, cinema, architettura…
«Tento di connettere le arti, dimostrare, tramite eventi come Parole al Vento, che si può fare educazione divertendo il pubblico, coinvolgendolo, mostrando e spiegando i percorsi mentali e creativi di grandi artisti. Cerco occasioni di incontro, dove ci si può scambiare saperi. Ah-Um è arrivato alla 23esima stagione, prima era un unico appuntamento annuale ora è sempre attivo attraverso molte iniziative, tra cui questa di cui stiamo parlando. Lo stesso titolo, Parole al Vento, offre un messaggio chiaro: dare agli spettatori più informazioni, chi vuole le coglie e le fa sue».
Lavoro che sta facendo anche Ferdinando Faraò con la sua Artchipel Orchestra…
«Con Ferdinando ci conosciamo da anni, ho visto nascere l’Archipel Orchestra! Lui da sempre è impegnato nella divulgazione».
Da amante della musica brasiliana, ho subito notato la serata del 4 maggio, Batuke – Storia sociale del Samba…
«Il Samba è genericamente visto come un’attrazione folklorica, il Carnevale, le ballerine e via dicendo. In realtà è molto radicato nella cultura del Brasile. Lo spiegheranno con parole e musica due bravi artisti, Nené, divulgatore e musicista, e Kal, percussionista che ha fondato varie scuole di musica a Milano, vedi Mitoka Samba. Loro sono i pilastri della cultura brasiliana in Italia. Prima della guerra in Ucraina il nostro obiettivo era, usciti dalla stasi del Covid, fare considerazioni forti sull’uso del corpo. Dopo il distanziamento obbligatorio e il conseguente cambiamento di comportamenti anche impercettibili che questo ha comportato, ci sembra interessante raccontarlo attraverso la metafora del Samba».

Kal dos Santos, a sinistra, e Nené Ribeiro, a destra, protagonisti di “Batuke: Storia Sociale del Samba”
Ogni incontro ha un tema che simbolicamente o realmente parla di condivisione…
«Stasera ci sarà Ferdinando che racconterà come nasce un progetto musicale condiviso e come si organizza un “corpo musicale”, i ruoli di ciascuno, le competenze… Anche la serata su Morricone, Inseguendo quel suono, avrà un coralità, sarà uno spettacolo a tre voci con lo scrittore e compositore Alessandro De Rosa, il chitarrista divulgatore Claudio Farinone e il fisarmonicista Fausto Beccalossi. Sulla base dell’autobiografia del maestro, ci saranno gli interventi dei musicisti…».
L’ultima serata sarà dedicata a Charles Mingus, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita…
«Sì, Mingussiana: Seven for Mingus vuole essere un omaggio al genio del musicista, che, fra l’altro, è il mio artista preferito. Qui la coralità, le connessioni saranno totali, visto che il sassofonista Tino Tracanna interpreterà alcune delle più belle composizioni del contrabbassista americano. Lo farà con un settetto di allievi del conservatorio Verdi di Milano. Verrà rispettato l’impianto dei brani, ma nelle improvvisazioni ognuno sarà libero di creare con il proprio strumento. Un omaggio alla libertà espressiva di Mingus!».
A parte gli appassionati, Parole al Vento, dovrebbe essere l’occasione soprattutto per i giovani di aprire la mente alla musica…
«I conservatori sono pieni di ragazzi che vogliono imparare a suonare jazz, ma ai concerti vengono sempre in pochi. Prendi il pop del momento. Ci sono artisti – pochi in verità – che hanno una qualche conoscenza musicale; nei loro brani “citano” altri generi, magari inconsapevolmente. Il resto è dominato da una povertà tematica, manca evidentemente la formazione, non c’è un racconto, piuttosto ci sono immagini fotografiche, da social. Certo, anche un’istantanea può essere raccontata, ma spesso senza andare a fondo, tutto rimane in superficie. C’è poca capacità di leggere la realtà. Questi nostri incontri sono un modo di concentrarsi, almeno per un’ora, su un tema».
Oltre a Parole al Vento ci saranno altri appuntamenti?
«Dal 21 al 24 giugno (il programma è in fase elaborazione) nelle piazze del quartiere Isola di Milano si terranno quattro giornate dedicate a quattro generi musicali diversi, Samba, Swing, Tango e Jazz. Presto saprò essere più preciso!».







 «Sto scrivendo un progetto che presenterò alla Berklee dal titolo The Human Web, dove mi concentro ad analizzare l’impatto dei social media, le condizioni economiche e fisiche, uno scontro che la pandemia ha ulteriormente accelerato. Sai sto seguendo quest’aumento vertiginoso di suicidi e tentati suicidi tra adolescenti, mi ha colpito molto. La mia idea è registrare questo nuovo progetto a Boston con musicisti residenti, a maggio».
«Sto scrivendo un progetto che presenterò alla Berklee dal titolo The Human Web, dove mi concentro ad analizzare l’impatto dei social media, le condizioni economiche e fisiche, uno scontro che la pandemia ha ulteriormente accelerato. Sai sto seguendo quest’aumento vertiginoso di suicidi e tentati suicidi tra adolescenti, mi ha colpito molto. La mia idea è registrare questo nuovo progetto a Boston con musicisti residenti, a maggio».