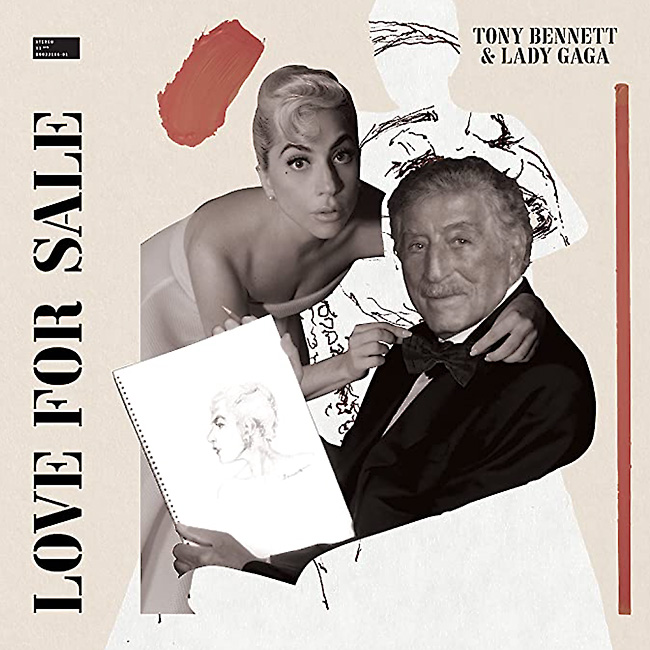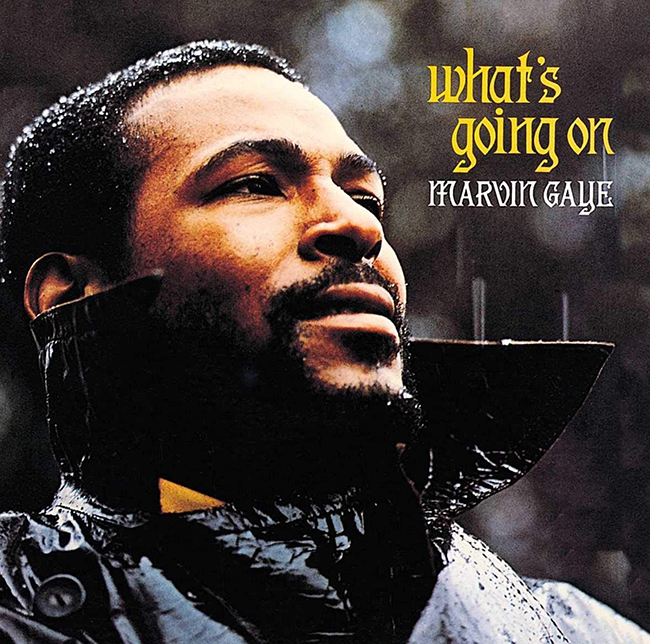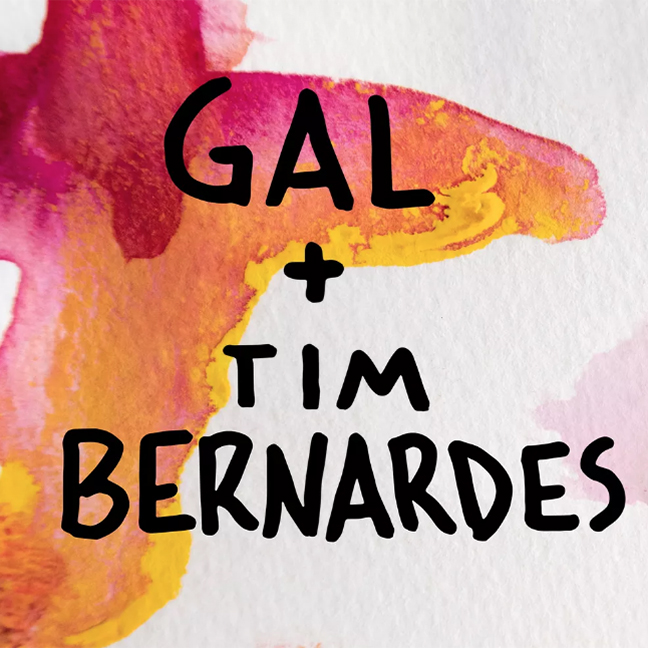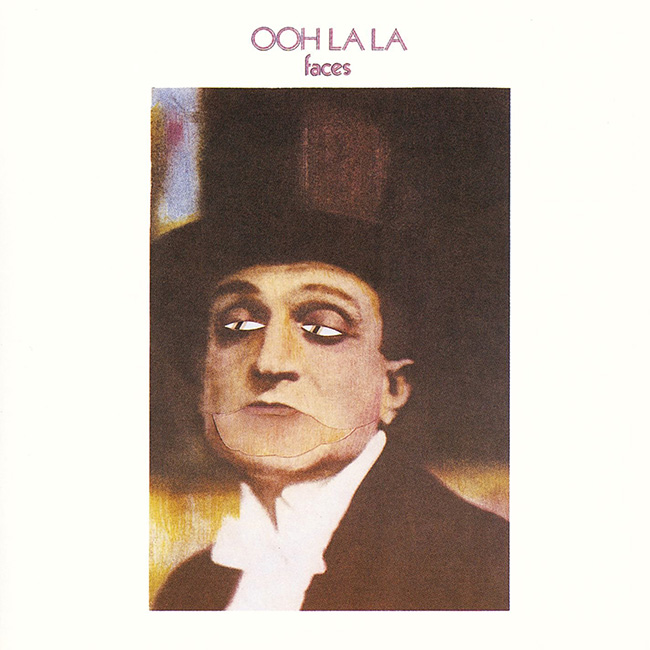Paolo Fresu – Foto Tommaso Le Pera
Se c’è un artista che, nonostante tutte le difficoltà dettate da due anni di pandemia, ha sempre guardato alla musica come un rimedio salvifico per l’anima e per il cuore, questo è Paolo Fresu. In quel terribile 2020 è stato uno dei pochi a continuare a proporre il suono della sua tromba, squillante o sussurrato, allegro o malinconico.
Artista prolifico, mai banale, creativo, pignolo, anche nella scelta delle copertine degli album pubblicati dalla sua Tǔk Music, label che ha fondato nel 2010 e che l’anno scorso a festeggiato i suoi primi dieci anni, con cui continua a promuovere giovani musicisti talentuosi o affermati jazzisti internazionali.
È uno che cento ne pensa e cento ne fa, tuffandosi nei continui progetti come se fosse Indiana Jones alla ricerca del suono perduto. Fresu ama la musica e fare musica. Non importa etichettarla, in fin dei conti per lui non è così essenziale. La musica ha tante facce, tante strade, tanti linguaggi, tutti hanno uno scopo e un valore.
Guardando al suo percorso artistico al numero di dischi che ha pubblicato, alle “enne” collaborazioni con jazzisti di tutto il mondo, si vede un musicista onnivoro, uno che non ha mai avuto paura di cambiare, che guarda sempre oltre, in preda a una curiosità infinita. Da Ostinato, il suo primo disco del 1985 con il Paolo Fresu Quintet, in attività dal 1984 (a proposito i cinque, oltre a Fesu Tino Tracanna al sax, Roberto Cipelli al pianoforte, Attilio Zanchi al contrabbasso ed Ettore Fioravanti alla batteria si esibiranno il 20 dicembre prossimo al Blue Note di Milano), passando per Inner Voices (1986) con il flautista Dave Liebman e sempre il Paolo Fresu Quintet, allo sperimentale e bellissimo Anaglifo (1997) con Nello Toscano e Rosanna Bentivoglio, A Mare Nostrum (2007), lavoro altrettanto interessante con Jan lundgren e Richard Galliano, ad Alma (2012) dove dialoga con un grande Jaques Morelenbaum e il cubano Omar Sosa, fino agli ultimi lavori, come la rivisitazione in chiave jazz della Norma di Vincenzo Bellini (2019) con l’Orchestra Jazz del Mediterraneo e Paolo Silvestri, In Origine: The Field of Repetance (2020) con SaffronKeira, un mito della musica elettronica, al secolo Eugenio Caria, sardo pure lui, al disco celebrativo dei suoi 60 anni, è tutto un cambiare, modificare, capire, reinterpretare.
L’ho incontrato a Milano a teatro dopo il suo Tango Macondo. Gli ho chiesto se aveva voglia di fare quattro chiacchiere con me per Musicabile. Ha acconsentito e dopo alcuni giorni ho ricevuto un appuntamento telefonico, da Monfalcone, dove si trovava per la tournée, spettacolo che, per inciso, ha appena aggiunto due date a Foggia, il 26 e 27 novembre, al Teatro Giordano. Il 4 dicembre sarà a Rovereto (Teatro Zandonai) per terminare a Roma dal 7 al 12 dicembre (Teatro Quirino).

Paolo, partiamo subito con Tango Macondo, oltre allo spettacolo, anche un disco, dove ci sono tre perle, Alguien Le Dice Al Tango, cantato da Malika Ayane, El Día Que Me Quieras, da Tosca e Volver, da Elisa…
«Tango Macondo è un esperimento, sinceramente non so cosa sia, se jazz o world music o qualcosa d’altro, non mi interessa. Con Malika, Tosca ed Elisa, artiste che provengono da mondi musicali diversi abbiamo dimostrato che ci sono tanti modi per unire la musica»
In fin dei conti, Tango Macondo è un viaggio nella fantasia e nella creatività…
«Anche se il libro da cui è stato ricavato è quello di Salvatore Niffoi, peraltro grande appassionato di musica, l’idea di un collegamento tra la Sardegna e l’America Latina mi era venuto leggendo un libro di Giovanni Maria Bellu, L’uomo che voleva chiamarsi Perón, dove si narrava che a Mamoiada vivesse un ragazzo di nome Giovanni Piras, partito per l’Argentina e che lì fosse diventato Juan Domingo Perón. Storia bellissima che provocò per un periodo la leggenda metropolitana di un sardo diventato il padrone politico del paese sudamericano. Alcuni finirono per credere davvero che Perón provenisse da Mamoiada. Ricordo che lessi il libro in un viaggio dalla Sardegna a Buenos Aires. Però il romanzo non aveva quel tipo di racconto tale da trasformarlo nella pièce teatrale che avevo in mente».
Con te sul palco ci sono Daniele Di Bonaventura, bandeonista, altro musicista che ascolto sempre con piacere, e Pierpaolo Vacca, un prodigio nell’organetto…
«Daniele è un grande bandeonista, ma non suona il tango. Il bandoneon è uno strumento che può fare di tutto: nasce in Germania, nelle chiese dove non potevano permettersi l’acquisto di un organo, come strumento sostitutivo. In Argentina con il bandoneon s’è suonato il tango. Pierpaolo è un grande esperto di musica tradizionale sarda: potrebbe suonare per ore senza mai fermarsi….».
Il rapporto tra l’Italia e l’America Latina è stretto…
«C’è un filo diretto tra il Sud Italia e il Sud America, un filo che unisce la musica brasiliana, il tango argentino e la musica italiana. La versione di Tosca di El día Que Me Queiras potrebbe essere benissimo una canzone napoletana di fine Ottocento! Non a caso anche Caetano Veloso è molto attratto dall’Italia e dalla sua cultura. Sono due mondi che si toccano di continuo, anche nell’idea melodica della musica. La migrazione è sempre a doppio senso, è normale che ciò avvenga».
Andiamo in Sardegna: sbaglio o l’isola ha molti bravi musicisti, una media altissima?
«È vero, la Sardegna ha una predisposizione per la musica, ma anche per il jazz! È un’isola musicale. Ha una storia ricca: tutti sono passati di qua per portarci via qualcosa, anche in tempi molto recenti, ma hanno pure lasciato qualche cosa. I sardi hanno imparato: abbiamo le launeddas (strumento a fiato tradizionale ad ancia semplice costituito da tre canne, ndr), il canto a cuncordu (simile a quello a tenore, tradizionale soprattutto nelle rappresentazioni della Settimana Santa, ndr), la musica monodica, la poesia orale dei poeti improvvisatori. Questa tradizione è stata reinventata dagli anni Ottanta in poi, e qui si arriva al jazz e ai numerosi appuntamenti sull’isola, dal festival di Cagliari (Festival Internazionale Jazz in Sardegna, ndr) al Calagonone Jazz Festival al Time in Jazz di Berchidda (creato dallo stesso Fresu nel 1988, ndr). Il jazz è musica di origine popolare e non a caso ha attecchito in Sardegna, dove ci sono musicisti, poeti, scrittori… Adesso questa musica e queste forme di poesia si muovono in direzioni nuove come Nanni Gaias, Salmo, i Menhir o Pierpaolo Vacca».

Paolo fresu – Foto Michele Stallo
Time in Jazz esiste da 34 anni, è un appuntamento irrinunciabile per chi ama jazz e contaminazioni…
«È un festival creato sostanzialmente per promuovere nuovi talenti. Attorno all’idea forte del festival continuano a nascere iniziative, tutte volte a diffondere la cultura musicale. L’ultima è Sa banda sa musica sa festa (qui su Facebook, ndr), progetto partito ai primi di ottobre che culminerà a dicembre. La banda di Berchidda ha incontrato la Funky Jazz Orchestra. Con l’aiuto di Corrado Guarino che segue la banda ogni 15 giorni, e di Dario Cecchini stanno preparando un grande concerto per il 28 dicembre a Sassari».
Berchidda è diventata, grazie a te, un centro culturale dove si fa musica e non solo.
«Senza la banda di Berchidda io non sarei qui. Ho iniziato a suonare la tromba da bambino nella banda. È lì che mi sono appassionato alla musica e sono diventato un musicista».
Time in Jazz e tutta l’attività che svolgi per il jazz e la cultura sono, dunque, il ringraziamento al tuo paese e alla tua terra…
«Pur vivendo a Bologna da anni, ho un grosso legame con Berchidda. Sul terreno dove mio padre allevava le bestie e coltivava la terra ho costruito il mio buen retiro. Mio padre era un pastore, della mia infanzia ricordo le pecore e la vigna. Il podere si chiama Tucconi. La mia etichetta discografica l’ho battezzata Tǔk, il toponimo di questo luogo rivisitato. Tutto torna, sempre: la banda, la casa discografica, il festival, la ricerca di nuovi talenti… Quest’anno il tema del festival non era Dante ma le stelle, care al poeta. Pietro Casu, poeta berchiddese, tradusse la Divina Commedia in sardo, molti passi li declamavano a memoria i pastori. Erano tradizioni orali. I poeti ottocenteschi, parole per la musica, vedi i Tenores di Bitti, il sottoscritto, Nanni Gaias, tutto si deve tenere…».
A proposito di Gaias: a gennaio l’ho presentato su Musicabile come uno dei giovani più promettenti, in occasione dell’uscita per la Tǔk Music del suo Ep T.O.T.B., Think Outside The Box assieme a un altro giovane chitarrista, Giuseppe Spanu…
«Nanni è di Berchidda ed è un bravo e promettente artista, anche lui si è formato nella banda del paese. Vedi, con lui tutto torna, è il motivo per cui in questi anni ho lavorato per la musica e per formare nuovi artisti. La Tǔk Music è stata creata perché tanti giovani musicisti mi inviavano i loro master da ascoltare o chiedevano consigli su come muoversi. Così mi son detto: “Perché non creare una label dedicata soprattutto a loro?”».

PAolo Fresu – Foto @seda
La Tǔk conta circa 170 artisti, un bel numero per una casa discografica…
«Siamo una grande famiglia, sono tutti artisti che hanno un pensiero simile al mio, oltre a essere bravi musicisti. Credo che un artista non sia solo lo strumento che suona ma il pensiero che ha dietro».
Di giovani musicisti portati al talento ce ne sono tanti in Italia, ma difficilmente emergono…
«Ce ne sono anche di importantissimi che non hanno la fama che meriterebbero. Forse siamo in tanti per un palco come l’Italia. In questo mondo complesso non c’è spazio, ma a volte manca quel coraggio per programmare altro. Se si investe bene i risultati si vedono, vedi il nostro Festival di Berchidda. La gente viene a vederci a prescindere dall’artista famoso, perché ci siamo conquistati la credibilità di proporre sempre musica interessante. Viene perché di noi si fida ed è curiosa di scoprire nuovi talenti. E poi il festival non è solo musica ma anche cinema, scoperta del territorio, letteratura. Alla Tǔk pubblichiamo i dischi che ci piacciono per una direzione comune, che, giuro, non so quale sia. Ritorno sulla tua osservazione: in Italia c’è poco coraggio nel fare scelte diverse dalle solite, finendo così per avere più o meno gli stessi artisti che girano, me incluso».
Dove sta andando al musica?
«Sono positivo. La musica si muove, punto. Ci sono cose molto belle in giro. Ciò che è importante è che la musica ci sia, avere una certa curiosità per gli altri linguaggi. Coloro che sostengono che il jazz sia morto con Coltrane sono morti dentro. Il jazz per sua definizione è apertura. Il nostro compito, quello che dovremmo fare ora, è cercare di aiutare il jazz e gli altri mercati musicali. Mi sforzo di aprire un po’ la mente. Ognuno di noi artisti deve farsi strada nel mercato musicale usando anche nuove tecniche e linguaggi. Lo spettacolo teatrale Tempo di Chet, a teatri chiusi per il Covid, ha avuto sul digitale una risposta incredibile, quasi 12 milioni di visualizzazioni. Occorre dare risposte creative e concrete rispetto al mercato. Bisognerebbe che anche la politica se ne rendesse conto, ad esempio per aiutare i jazz club».
Cosa ti spinge nel tuo lavoro, di musicista e discografico?
«Una grande creatività. Attingo da tutto, mi piace ascoltare tutto, rispondo sempre a tutti. Quando un giovane ti manda un master devi rispondere, perché le persone attendono sempre una tua risposta. Sono stato educato così. Poi, vicino a me ho persone come Luca Devito, grandissimo appassionato di musica, che mi propone di tutto. A tal proposito, mi appassiona moltissimo, per esempio, Venerus. Poi ho mio figlio che, da adolescente, mi fa scoprire cose straordinarie. La mia non è bulimia, ma attenzione. Mi piace provare, sperimentare anche se poi, come in cucina, non tutte le ciambelle escono col buco! Nonostante i miei 60 anni l’idea dell’ascolto la reputo fondamentale, altrimenti si finisce col paraocchi. Come a tavola, se non assaggi un cibo non sai se sia cattivo o buono, così nella musica, se mi arriva un disco lo ascolto, se non mi va non mi faccio del male e lo lascio perdere, se mi colpisce, beh, allora, l’ascolto ne è valso davvero la pena!».