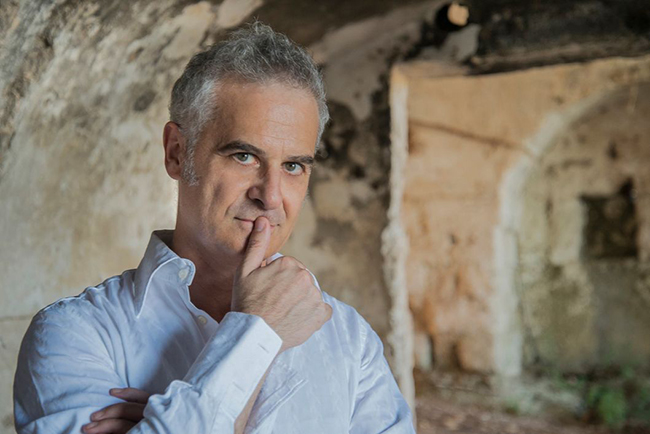Oggi esce su tutti gli scaffali, fisici e digitali, Let me Play, Let me Pray, il nuovo lavoro di Nico Morelli, pianista di Taranto da anni residente a Parigi. Di lui e della sua musica vi avevo parlato in un post uscito nel maggio di due anni fa. La casa discografica è la Tǔk Music, sempre attenta a proporre artisti mai banali né tantomeno scontati. Un disco in piano solo è un’arma a doppio taglio, così almeno la pensa lo stesso Morelli, momento importante per la carriera di un musicista ma anche piuttosto rischioso, visto che un intero album suonato sempre dallo stesso strumento può stancare l’ascoltatore.
Per evitare la noia Nico ha tirato fuori il meglio del suo sapere far arte: un lavoro di 56 minuti per 16 brani, inciso rigorosamente live, senza post produzioni, dove il protagonista è il pianoforte, in questo caso uno Steinway and Sons della serie D, a coda, con un suono potente, caldo e ricco di sfumature. Unito, però, a una loop station, una diamonica (strumento ad ance con tastiera), un tamburello e la cassa del piano usata come percussione. Oltre agli strumenti estemporanei che usa regolarmente durante i suoi concerti solisti, Morelli si è avvalso anche dell’aiuto di due sound designer che hanno modificato il suono in presa diretta, trasformando il pianoforte, come un camaleonte, in cascate di suoni eterei, chitarre elettriche, campanelle.
Continua a leggere