
Domani alle 17:30 all’Auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano parte la XXXI edizione dell’Atelier Musicale, rassegna di jazz e classica contemporanea organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio (ingresso 10 euro). Una rassegna che negli anni è cresciuta ed è diventata un appuntamento immancabile nella proposta musicale meneghin. Il concerto inaugurale è stato affidato non a caso a uno dei nostri grandi artisti jazz, Claudio Fasoli, mitico sassofonista dei Perigeo, compositore, insegnante, musicista che ha fatto del jazz la ragione di vita, di lavoro e di studio.
Nell’aprile scorso Claudio ha pubblicato il suo secondo libro (il primo, Inner Sounds, è uscito nel 2016) dal titolo Jazz, architetture di un azzardo (il Saggiatore, 200 pag, 18 euro), che via consiglio caldamente di leggere. Dentro ci trovate la summa del musicista, lo studio, la composizione, i concerti, l’insegnamento, la promozione del jazz, note tecniche per chi di musica ne sa ma anche curiosità, ricordi e storie di un genere che dalla sua nascita è in continuo cambiamento e innovazione che ha portato Claudio a dare una definizione di jazz che ho trovato fantastica: un azzardo.
La musica è un linguaggio e in quanto tale si base su un’architettura condivisa. Architettura che, come in tutte le lingue parlate nel mondo, supporta una continua evoluzione, neologismi, nuove parole, nuove forme lessicali. Nel jazz le architetture della musica riescono a “stare in piedi” grazie alla creatività, all’uso delle note e dei cluster che sembrano apparentemente incomprensibili ma che in realtà riescono costruire “edifici sonori” solidi e avveniristici. Tutto questo è possibile grazie, appunto, all’azzardo. Che non è una scommessa, dietro c’è uno studio lungo e costante, la voglia di cercare nuove forme musicali.
Con Claudio avevo fatto una bella chiacchierata alcuni anni fa (qui l’intervista). L’ho chiamato l’altro giorno per parlare del libro e della sua musica.
Partiamo dal concetto di azzardo, cos’è applicato al jazz?
«Quando tu parli sai qual è il tuo pensiero ma non sai ancora con che suoni lo dirai, con quali vocali, consonanti… Hai varie possibilità con le quali puoi formulare dei pensieri. L’azzardo è esattamente questo, il momento in cui tu scegli una via di comunicazione verbale diversa da altre, può essere efficace, meno efficace o addirittura sbagliata, può avvenire in una lingua straniera, può fermarsi a metà perché hai starnutito! Gli azzardi sono qualsiasi fatto che comporti una scelta. Ti dico di più, addirittura nel momento in cui leggi delle parole scritte, quindi già previste, hai mille possibilità interpretative. Lo ha dimostrato Gassman, quando leggendo passi di libri o poesie, interpretava un testo. Allo stesso modo, quando un pianista classico apre delle pagine, ha un testo, e questo testo ha mille possibilità diverse, minuziose, sottili. Ma se tu vieni interpellato e rispondi, lì puoi farlo improvvisando, anzi, improvvisi rispondendo. Ecco, nel jazz non si parla di suoni verbali, ma di suoni musicali, questa è l’unica differenza».
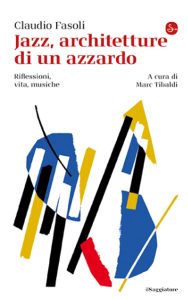 Nel libro parli del silenzio come elemento importante della musica. Però fai anche notare che, per esempio, John Coltrane con il suo Quartetto dialogava in modo serrato e che quei dialoghi erano ipnotici, i musicisti sapevano quando e come intervenire… Non era caos!
Nel libro parli del silenzio come elemento importante della musica. Però fai anche notare che, per esempio, John Coltrane con il suo Quartetto dialogava in modo serrato e che quei dialoghi erano ipnotici, i musicisti sapevano quando e come intervenire… Non era caos!
«Certo che no! Si parla di uno dei grandi maestri del Jazz: Coltrane aveva adottato un atteggiamento “logorroico”, non ha mai suonato tanto per suonare, ma solo per dire cose importanti. Ha scelto questa strada, malgrado io possa pensare che in certi momenti era esageratamente sovraccarico di note. Coltrane è Coltrane proprio perché ha scelto quel suono, e quei musicisti. È chiaro che gli azzardi erano molteplici, perché negli accordi che metteva McCoy Tyner (il pianista del quartetto) Coltrane non poteva sapere quali note sceglieva, visto che i simboli degli accordi lasciavano ampia scelta al pianista di cercare suoni più gravi, più alti, ritmicamente costruiti in una certa maniera. Mi raccontava Elvin Jones (il mitico batterista del quartetto, ndr) che durante i cosiddetti matinée (si esibivano negli aperitivi), andavano sul palco e Coltrane cominciava subito a suonare, gli altri lo seguivano in automatico. Se cominciavano alle sei, alle 7:30 Coltrane finiva il suo solo, senza mai fermarsi un secondo. Mettevano via gli strumenti e andavano a casa. Giocava sui suoi moduli, sulle sue cellule liberamente, secondo un progetto mentale che era appunto l’architettura. Ed era quello l’azzardo che lui poi otteneva».

Il Next Quartet. Da sinistra, il contrabbassista Tito Mangialajo Rantzer, il batterista Stefano Grasso e il chitarrista Simone Massaron.
Lo stesso discorso vale quando parli dei fratelli dei fratelli Shorter, Alan e Whyne, addirittura tra di loro parlavano in un linguaggio incomprensibile…
«Sì, infatti lì… praticamente c’era più di un azzardo. La sfida era di non essere capiti. Se tu vai in Finlandia, Svezia o Germania e non conosci le lingue rispettive, puoi chiedere una strada ma loro ti guardano straniti perché non capiscono niente. La comunicazione ha sempre impliciti degli azzardi. Anche perché certe volte dici delle cose per bene e vieni interpretato male».
Oggi, soprattutto sui social, ci sono giovani musicisti che mostrano il loro virtuosismo, pochi secondi dove l’emozione non conta. L’importante è stupire. Non c’è il pericolo che la musica diventi solo un mezzo per dimostrare quanto uno è unico?
«Hai usato la parola “giovani”, il termine implica che ovviamente questi “giovani” devono maturare un pochino, bisogna dargli tempo. Già loro studiano molto e hanno ottenuto questa qualità tecnica importante. Molti amano questo tipo di espressione, altri usano dei moduli più pacati, più semplici, dei silenzi, delle pause… Questi giovani che scoprono di avere studiato e di avere capito tante cose, ovviamente fanno vedere quanto sono bravi tecnicamente, pensano che quella sia il fattore determinante. È come se tu ti mettessi un vestito particolarmente bello, perché pensi sia adatto, con i pantaloni stirati, la camicia bianca e la cravatta rossa, tutto molto elegante, per andare a fare un giro in barca. È questione di opportunità. Noi viviamo nell’azzardo, perché facciamo continuamente delle scelte, di fare una strada più lunga ma più tranquilla, oppure la più corta ma più frequentata, succede tutti i giorni. Queste scelte le facciamo anche nella musica».
Quindi l’architettura per un musicista è…?
«…La partitura e l’azzardo è quello che può saltarne fuori».
Azzardo coincide con creatività, perché se non osi non puoi mostrare ciò che puoi creare, dove puoi andare con il tuo linguaggio…
«Infatti non puoi mostrare le tue emozioni e nemmeno il tuo pensiero. La musica è una comunicazione di emozioni. I suoni sono veicoli di emozioni, sia che siano verbali sia che siano sonori».
Mi sono appuntato una tua frase che mi è piaciuta molto: “Scrivo musica che possa aiutare chi vuole esprimersi improvvisando”. Cosa vuoi dire?
«Sì, scrivo la musica senza pensare di affrontare lì dei problemi di carattere tecnico. Il telaio, cioè l’architettura, può essere più complessa o meno complessa. Prendi Giant Steps di Coltrane, un brano che in sé non è difficile, ma eseguendolo molto velocemente l’ha reso complesso. Mi ricordo che lo proponevo quando insegnavo nei primi corsi a Siena. Lo facevo per amore del paradosso: i primi giorni dicevo ai miei allievi, badate che alla fine del corso noi suoneremo Giant Steps. Chi lo conosceva diceva: “Non ci riusciremo mai!”. Quello che ho fatto è stato adottare un tempo lentissimo, in certi momenti addirittura quasi senza. Solo così si sono accorti che la difficoltà era sostanzialmente… il tempo: eseguendolo lentamente, era addirittura un brano banale, per nulla difficile».
Un’altra tua affermazione che mi sono segnato: “No, non voglio avere limiti o pregiudizi”. Ovvero, devo essere libero per poter creare. È così?
«Ma sai, il concetto di libertà non può esistere in assoluto. È chiaro che non posso dire al batterista piglia una pentola sporca di sugo di pomodoro e picchiala lì a metà nel brano numero 25! Va bene una libertà, ma ovviamente in un ambito condiviso, cioè il batterista sarà libero di improvvisare mentre io sto improvvisando perché tutti improvvisano su un telaio che è il brano. Ovviamente, parlando insieme è naturale che ci siano dei rischi, magari un accordo viene messo in un punto non opportuno, oppure il telaio in quel momento prevedeva una pausa e questa è stata cancellata. Insomma, ci sono molti azzardi, ecco, perché al di là dell’interpretazione, c’è l’improvvisazione».
Il jazz per sua definizione è sempre stato cambiamento, assorbe, prende da tanta musica, ma anche dalla società, da come questa si sta evolvendo. Come lo vedi rispetto a quando suonavi nei Perigeo? Eravate gli Weather Report italiani!
«Non ho censure, ascolto un po’ di tutto. Il fatto che ci siano molte scuole, bravissimi maestri e dunque musicisti preparati sul piano tecnico e improvvisativo è un ottimo dato! Ai nostri tempi eravamo tutti un po’ autodidatti. Jackie McLean abitava nello stesso palazzo di Bud Powell e andava da lui a imparare gli accordi. Allora non esistevano libri di studio, si suonavano soprattutto le canzoni di Broadway, i cosiddetti standard, che poi sono diventati il linguaggio base. Finché non è arrivato Horace Silver – ed altri come lui – dove il jazz si è trasformato anche in composizione, prima era soprattutto improvvisazione. C’era stato Lenny Tristano, un gigante sempre disatteso, mai abbastanza conosciuto. Non se ne parla mai, ma lui era avanti decine di anni nel suo messaggio e in certe storie del jazz non viene nemmeno citato. Ora tutto questo tecnicismo certamente è un dato positivo, però bisogna saperlo gestire. Perché il tecnicismo è legato alla maturità espressiva, a quello che uno vuol dire. Nella musica ormai ci sono tantissime persone interessanti che hanno una grande maturità pur essendo giovani. Ci sono pianisti come Aaron Parks, Shai Maestro, David Virelles, Matt Mitchell, poco conosciuto, ma grandissimo. C’è un sassofonista canadese molto interessante anche nella sua articolazione compositiva, Ben Wendel, un bassista come Matt Brewer, magnifico. Con Mitchell ho fatto due dischi e ti assicuro che è un pianista straordinario, molto avanti. Alcune sue composizioni sono estremamente difficili. Io mi incarto, perché quando è così complessa diventa anche un po’ angosciante. Ed è proprio l’angoscia l’emozione che lui vuole comunicare».


