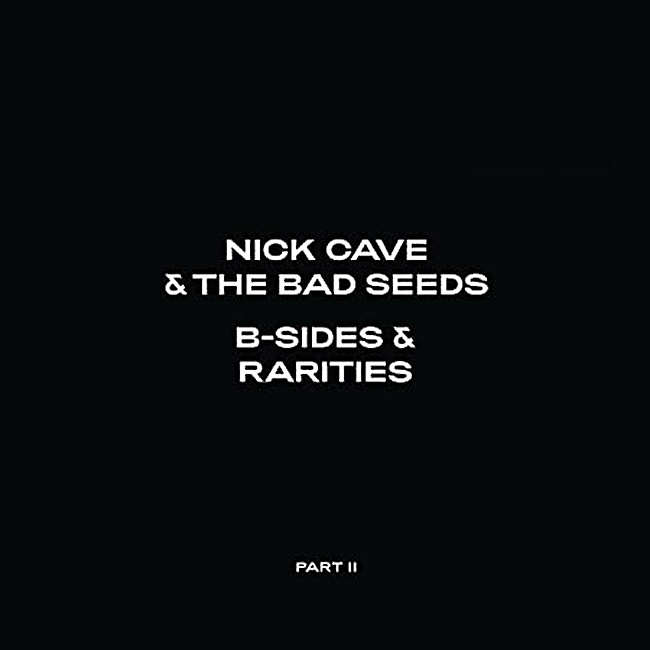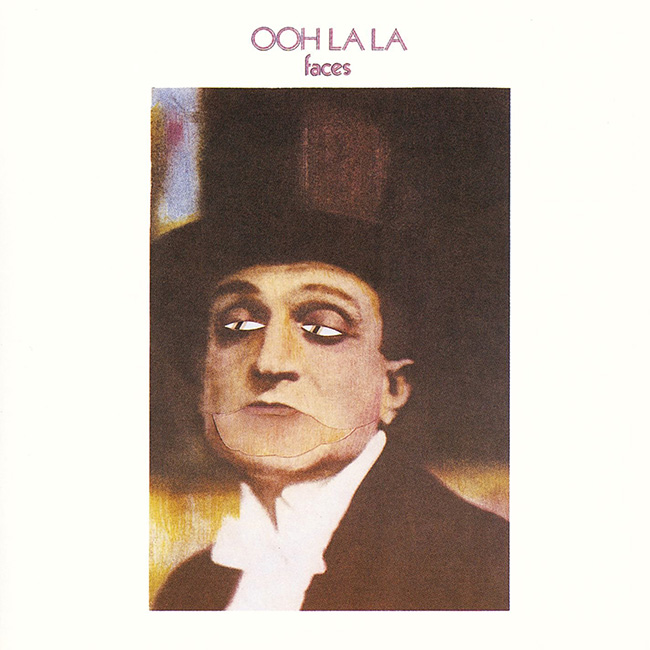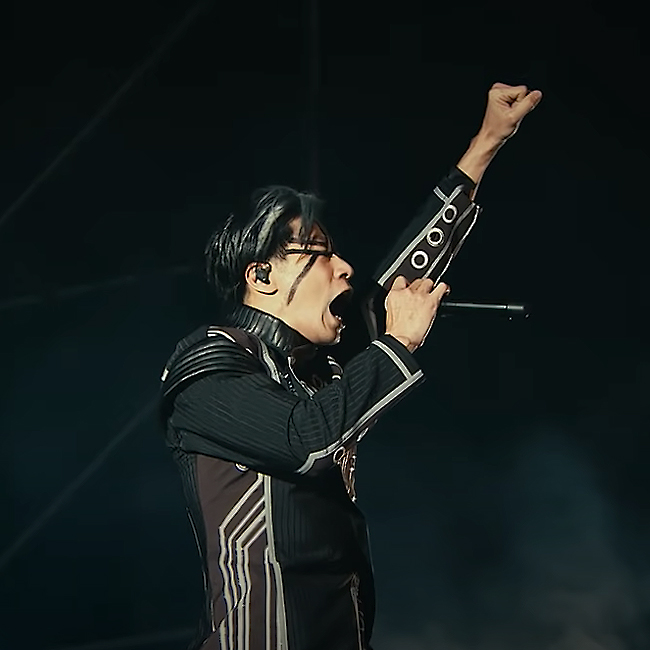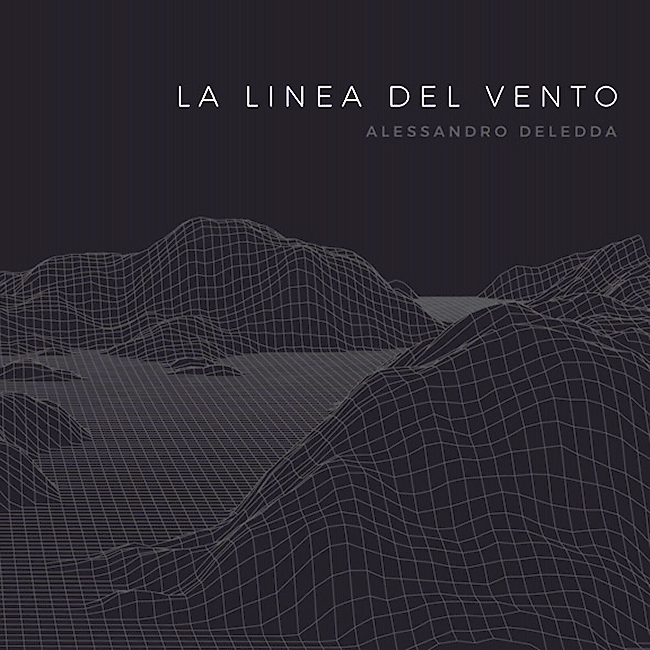Il 2021 s’è chiuso da pochi giorni. Un anno in musica che, dal mio piccolo osservatorio, ha rivelato molti lavori di buona qualità. In tutti i generi, dal rock al jazz all’alternativa, classificazione usata per dire tutto e niente. Mi sono esercitato in una mia personale classifica dei dieci album che che mi sono piaciuti di più. L’ho stilata in base ai miei gusti, alle mie aspettative, alle mie sensazioni ed emozioni. Di dischi ne ho ascoltati centinaia, molti mi hanno annoiato a morte ma altri mi hanno catturato. Questi dieci sono quelli che ascolto con rinnovato piacere quando lavoro, leggo, mi rilasso. Praticamente tutti li ho già pubblicati nel corso dell’anno, con un paio di artisti ho chiacchierato anche a lungo… Ve li propongo tutti e dieci in rigoroso ordine di pubblicazione, divisi in due post…Qui i primi cinque.
Per Aspera Ad Astra – Daniela Spalletta – 5 febbraio 2021
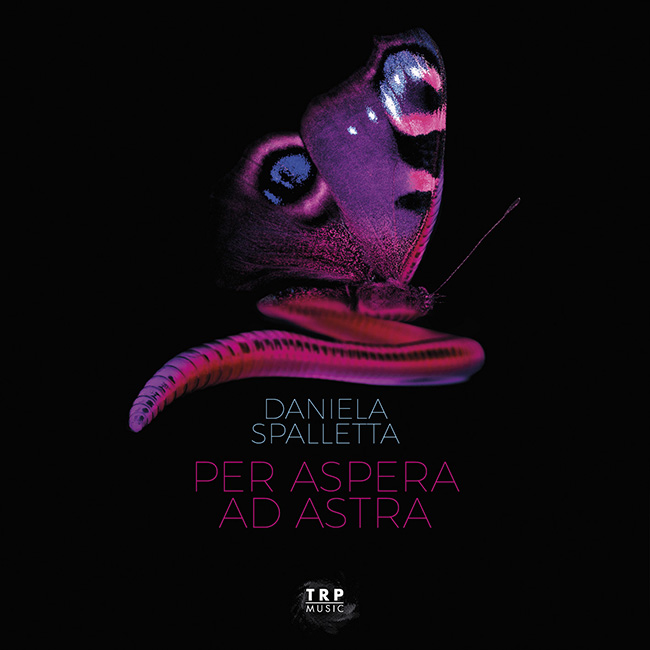
Daniela Spalletta, siciliana, 39 anni, è una delle voci più interessanti e complete del panorama jazzistico italiano e internazionale. Ha all’attivo tre album solisti D Birth (2015 – Alfa Music), Sikania (2017 – Jazzy Records) e Per Aspera Ad Astra (TRP Music) uscito a febbraio. Troppo poco conosciuta dal grande pubblico, e questo è una grande sfortuna per chi non l’ha mai ascoltata, visto che, con la voce che si ritrova, la Spalletta potrebbe cantare di tutto. Usa la voce come strumento, ma è una musicista che compone e arrangia e la riprova è proprio quest’ultimo lavoro, frutto della sua creatività e studio. C’è jazz, certo!, ma c’è anche world music, c’è classica e un brano che mi ha stregato, un ricordo di musica barocca rivisitata in Rosa, dove tecnica e passione si fondono “angelicamente”. Un lavoro dalla costruzione complessa, grazie anche ai musicisti che la accompagnano, persone che si conoscono da anni e che da anni suonano insieme. Dagli Urban Fabula (Seby Burgio al pianoforte, Alberto Fidone – che ha suonato nell’album ma ha anche curato la direzione della TRP Studio Orchestra, l’orchestra d’archi, e ha prodotto il progetto con la Spalletta – al contrabbasso e Peppe Tringali alla batteria) al chitarrista sloveno Jani Moder, formatosi in quella straordinaria fucina che è il Berklee College of Music di Boston, a Riccardo Samperi, ingegnere del suono, che Daniela ha definito «il quinto uomo del quartetto». Approvato a pieni voti!
Carnage – Nick Cave & Warren Ellis – 25 febbraio 2021
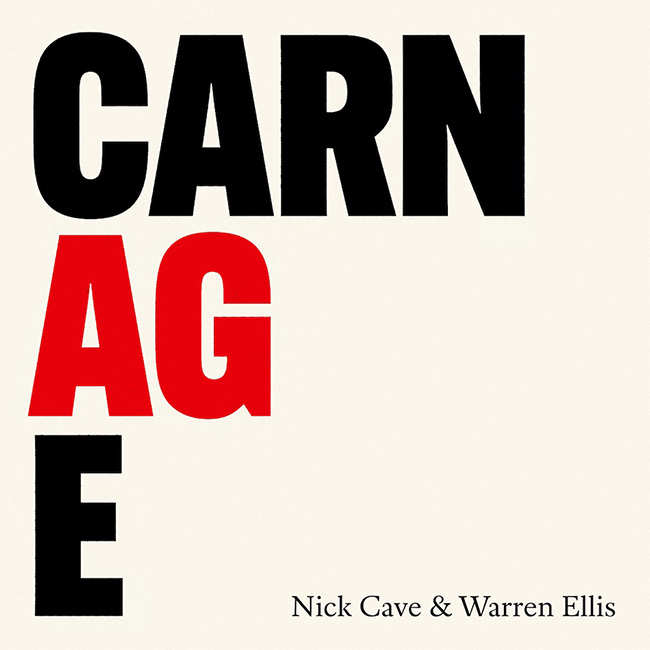
Nick Cave & Warren Ellis. Con questi due artisti non poteva che uscire un lavoro di altissimo livello. Carnage, carneficina, è un disco che impatta, fa male, ti rigira senza troppa gentilezza. Scritto durante il lockdown, è un lavoro di pesante riflessione sulla solitudine arrivata con la pandemia, sul credere in qualcuno o qualcosa, su quello che siamo oggi, con l’inconfondibile voce baritonale di Nick e praterie di sintetizzatori made in Warren, piccoli interventi di chitarre elettriche secche come la solitudine, il pianoforte suonato da Nick che tesse melodie, in realtà, note di speranza. In Balcony Man, ultimo degli otto brani che compongono questo mosaico baritonale, profondo, essenziale, Nick canta: This morning is amazing and so are you/This morning is amazing and so are you/ This morning is amazing and so are you/ You are languid and lovely and lazy/ And what doesn’t kill you just makes you crazier. Quest’ultima frase è epica: «Ciò che non ti uccide ti rende solo più pazzo», una sintesi perfetta per due anni di pandemia. In Hand of God, «Hand of God /Coming from the Sky», primo brano, dopo un inizio “classico”, scarica sull’ascoltatore un ritmo ossessivo, profondo. Nella splendida Old Time, dove, per inciso, alla batteria c’è un altro storico “Bad Seeds”, Thomas Wydler, Nick canta: «I sogni di tutti sono morti, ovunque tu sia andata, tesoro, non sono così indietro». Tasselli che raccontano la solitudine ma anche la speranza di ritornare un giorno a una normalità. Pregno ed epico White Elephant, un chiaro riferimento all’estrema destra americana. Parte con un’elettronica alla Peter Gabriel anni Ottanta per finire in una sorta di gospel. Qui è il primatista bianco che minaccia di uccidere tutti, si sente dio, «Una Venere di Botticelli con il pene», ma anche «Una scultura di ghiaccio che si scioglie con il sole»…
Smiling With No Teeth – Genesis Owusu – 5 marzo 2021

Smiling With No Teeth è il primo album di questo ventitreenne nato in Ghana e cresciuto a Canberra (Australia), dove i suoi genitori lo portarono all’età di due anni. La famiglia è ritornata in Ghana, lui divide la sua vita tra i due Paesi. Il fratello maggiore è un rapper noto in Australia, Citizen Kay. Premessa necessaria: Genesis adora i manga giapponesi, i videogiochi e in genere le arti visive. E ancor di più ama alla follia le musiche dei videogiochi, oltre al funk, al punk, al rap e al pop. Queste sue passioni si riversano tutte nel disco che riassume un caos di generi dove Owusu si muove a suo agio, alimentandolo a dovere. Si sente la stessa fluidità di Prince nel fare musica… A partire dal primo brano, On The Move che introduce The Other Black Dog, è un crescendo di melodie e generi che stimolano e incuriosiscono. Ti invogliano ad andare avanti per questa strada apparentemente sconnessa – vedi Waitin’ on Ya – e divorare il disco fino all’ultimo brano, By By.
We Are – Jon Batiste – 19 marzo 2021
 Jon Batiste, è un artista di New Orleans, famoso negli States per essere il direttore musicale del The Late Show condotto da Stephen Colbert. Il suo lavoro, We Are, è un album che trasmette energia allo stato puro, emozione, disperazione, commozione, pur conservando un grande rigore musicale nel mix stilistico. Un album “impegnato”, sull’onda del Black Lives Matter. C’è soul, pop, hip-hop, rap, R&B, con un pizzico di maestria jazz, ingredienti di un’insalata condita alla perfezione. Ascoltate We Are, il brano che apre il disco, cantata assieme alla St. Augustine High School Marching 100 e il Gospel Soul Children’s Choir di New Orleans, dove la parola “freedom” è una costante. Freedom è anche il titolo di un altro brano… In un crescendo la creativa sequenza di Batiste si sussegue a ritmo serrato, passando per Tell The Truth, un’intemerata alla Otis Redding e agli anni Sessanta, all’incontenibile I Need You, e così per tutti e 13 i brani, belli spessi.
Jon Batiste, è un artista di New Orleans, famoso negli States per essere il direttore musicale del The Late Show condotto da Stephen Colbert. Il suo lavoro, We Are, è un album che trasmette energia allo stato puro, emozione, disperazione, commozione, pur conservando un grande rigore musicale nel mix stilistico. Un album “impegnato”, sull’onda del Black Lives Matter. C’è soul, pop, hip-hop, rap, R&B, con un pizzico di maestria jazz, ingredienti di un’insalata condita alla perfezione. Ascoltate We Are, il brano che apre il disco, cantata assieme alla St. Augustine High School Marching 100 e il Gospel Soul Children’s Choir di New Orleans, dove la parola “freedom” è una costante. Freedom è anche il titolo di un altro brano… In un crescendo la creativa sequenza di Batiste si sussegue a ritmo serrato, passando per Tell The Truth, un’intemerata alla Otis Redding e agli anni Sessanta, all’incontenibile I Need You, e così per tutti e 13 i brani, belli spessi.
Vulture Prince – Arroj Aftab – 23 aprile 2021

La voce di Arroj Aftab ti inchioda, la sua musica, contaminata da jazz, ritmi afrocubani, dal samba e, ovviamente dalle melodie tradizionali del suo Paese d’origine, il Pakistan, è la dimostrazione di come le culture si possano fondere armoniosamente e far nascere qualcosa di nuovo e importante. Dopo Bird Under Water, primo disco uscito nel 2014 – ascoltate la ninnananna Lullaby – Sirene Islands, del 2018, quattro brani per 48 minuti e 15 secondi di ascolto, pura elettronica, musica meditativa – qui Ovid’s Metamorphoses – ecco Vulture Prince, un disco che doveva essere la naturale continuazione del precedente Sirene Islands, con un ritorno, però, all’uso di strumenti quali la chitarra, l’arpa, i violini, nella quasi totale assenza di percussioni, un forte richiamo alla musica urdu, un neo-sufi con influenze jazz, folk, persino reggae. Il tutto suona non come una semplice contaminazione di generi, ma con uno studio attento e rispettoso della musica da cui Arooj ha attinto. Doveva essere anche un disco più “sostenuto”, come lei stessa ha avuto modo di spiegare in un’intervista a NPR, emittente radiofonica americana, con iniezioni di Afrobeat, poi, una tragedia familiare, la morte di Maher, il fratello più giovane a cui era molto unita, l’ha portata a fare scelte più rispettose del lutto che si era imposta. Ne è nato un lavoro di grandi emozioni. Da Diya Hay, brano per lei significativo, perché è l’ultima canzone che ha cantato al fratello, registrato con la brasiliana Badi Assan, alla sua personale versione del Mohabbat, un ghazal, poema tradizionale (famosissimo), che parla d’amore, ma anche di dolore per la perdita della persona amata, fino a Last Night, il testo è un poema di Rumi, il grande poeta persiano vissuto nel Duecento, che lei ha messo in musica (reggae) nel 2010 e che ha deciso di incidere in questo disco.