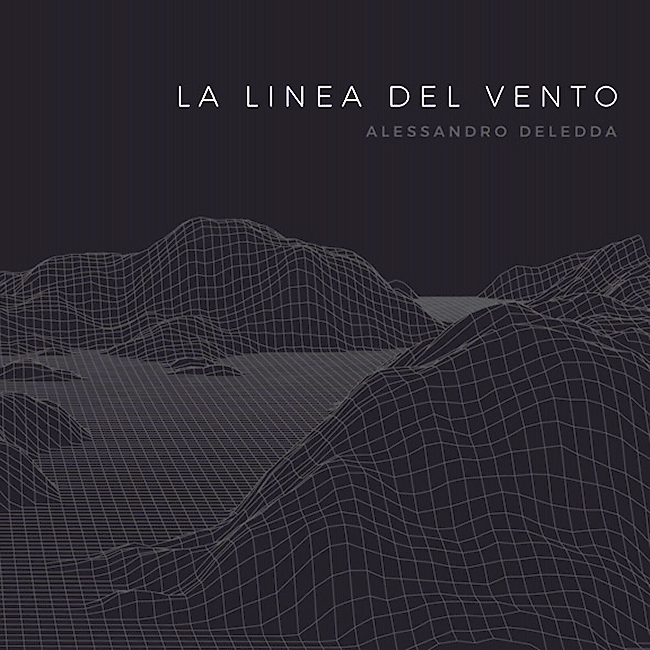Può sembrare strano che vi parli di Kpop, il pop Coreano, genere mainstream costruito a tavolino dove la musica non è la protagonista principale, ma appena una comprimaria. Dove tutto viene deciso fin nei minimi particolari, in una sorta di rigorosa catena di montaggio che finisce per rappresentare la negazione della musica e dell’artista stesso, sacrificati a un bene maggiore: la felicità dell’ascoltatore e i conseguenti lauti introiti di un sistema oliato alla perfezione.
Il Kpop andrebbe studiato a fondo per capire come sia riuscito a sfondare nel mondo occidentale, quali siano i suoi segreti per conquistare a strascico migliaia di adolescenti e giovanissimi adulti.
Ho deciso di parlarne perché ho conosciuto un trentenne romano, Fabio Demofonti, in arte KBLUE, che s’è innamorato del genere al punto da farlo diventare il suo lavoro. Da un paio d’anni vive in Corea del Sud, s’è messo a studiare Kpop con abnegazione, ogni giorno ore e ore di concentrazione e fatica tra lezioni di canto, lingue, ballo, esercizi obbligatori in palestra, prove su prove. Diventare un “Idol” è difficile, come vincere al Superenalotto, ma chi ci riesce si aggiudica il jackpot!
Ora mi direte: ma cos’è, uno scherzo? No affatto, anche perché Fabio ha una solida cultura orientale alle spalle, coltivata sin da piccolo. Sa parlare correttamente il cinese – lo ha studiato in una università in Cina – il coreano, il tagalog, la lingua filippina, oltre, ovviamente all’inglese e ad altre lingue/dialetti asiatici. Nelle Filippine è diventato una star, grazie ad alcuni fortunati singoli.
Dopo averci riflettuto a lungo, ho deciso di chiamarlo. Ci siamo dati appuntamento a un’ora accettabile per lui e per me visto il fuso orario e i suoi impegni di studio e lavoro, e ci siamo presentati… Due realtà opposte a confronto!
Fabio raccontami di te: perché ti sei appassionato al Kpop e alla Corea del Sud?
«Probabilmente in più vite precedenti devo essere stato un coreano o quanto meno, un asiatico, perché ho sempre avuto un’attrazione per tutto ciò che riguarda l’Asia e la sua cultura in generale. Dieci anni fa sono andato a studiare il cinese in Cina, all’università. Il Kpop l’ho scoperto lì: in quel periodo lavoravo in una discoteca. Una sera, il dj mette una canzone e vedo che tutti quanti iniziano a ballare allo stesso modo, all’unisono. Sorpreso, vado subito dal disk jockey a chiedere informazioni. Era una band KPop. Quel genere mi ha coinvolto e affascinato fin da subito: come poteva un brano avere la forza di far danzare una discoteca intera allo stesso modo, tutti perfettamente sincronizzati? Quel gruppo non esiste più, s’è sciolto. È un’altra caratteristica del genere: una band non dura più di 7/8 anni, salvo che non rinnovino i contratti. In quell’istante ho deciso che sarei diventato il rappresentante italiano del pop Coreano».
Quanto incidono le label sulla nascita di queste pop band? C’è un mercato mostruoso!
«Le case discografiche sono determinanti. Innanzitutto perché hanno la disponibilità di farti crescere e investono tantissimi soldi. Ti parlo in base alla mia esperienza: la formazione di cantante KPop è un grosso investimento di tempo e di denaro. Non so se hai visto i video dei cantanti coreani: altro mondo rispetto a quelli italiani. Il video è il vero biglietto da visita dell’artista, e, in quanto tale, viene curato nei minimi dettagli. Le case discografiche poi sono fondamentali nella scelta dei componenti del gruppo. Seguono un format oliato: c’è il rapper, immancabile, il ballerino, la voce solista…».

Quindi, le case discografiche fanno molto scouting…
«Sì, in molti modi. Per esempio, qui ci sono tantissimi artisti che cantano per strada. Si propongono apposta nella speranza di essere adocchiati. Poi ci sono i provini, le audizioni. Ti presenti con il tuo brano, canti, balli, in base alle tue competenze. Ogni casa discografica ne organizza in modo costante. È figo perché ci sono tantissime persone che si presentano».
Cos’è che ti colpisce del fenomeno Kpop…
«A livello musicale, respiri il futuro, perché è tutto ricercato, moderno. È l’evoluzione dei generi nati in Occidente. È un pop che ha suoni molto sofisticati e innovativi rispetto al nostro mercato europeo e mondiale. E poi sono super vibe-positive».
Dalla tua esperienza, solo un’evoluzione del pop occidentale?
«Il Kpop, letteralmente, è la versione coreana del pop. I primi gruppi degli anni Novanta, maschili e femminili, si basavano sulle Spice Girl o sui Backstreet Boys. Poi c’è stata un’evoluzione totale. Oggi le boy/girlband mondiali sono pochissime. Di quelle rimaste, praticamente solo le inglesi Little Mix sono le uniche che ballano e cantano. Mentre qui avere una coreografia in quasi tutti i video è importante. Ciò impone una formazione costante, lo vedo io stesso: ore e ore di canto, ballo, preparazione atletica, stretching. Tanta fatica viene ripagata, io stesso ho registrato un miglioramento enorme. I generale, le voci particolari, e noi ne abbiamo tante, vedi per esempio Gianna Nannini, non vengono prese in considerazione perché… non sono “cool”».
Quanti gruppi ci sono attualmente in Corea?
«Non li ho mai contati, comunque tanti, e ne escono continuamente di nuovi. I BTS (quelli che lo scorso anno sono entrati di prepotenza nelle classifiche degli States, ndr) vengono dalla Hybe, casa discografica che ha avuto solo boyband, gruppi di “idol” maschili. Una decina di giorni fa la label ha pubblicato il suo primo gruppo femminile. Le principali case discografiche, vedi la SM, la YG Entertainment, quella delle Blackpink, la P Nation, fondata da PSY (ricordate il tormentone Gangnam Style?, ndr) quest’ultima tratta solo cantanti e non boyband, hanno grandi mezzi a disposizione. Tra l’altro, PSY ha pubblicato recentemente un nuovo disco, PSI 9th, l’hai ascoltato?».
No, ho ricevuto il comunicato stampa ma…
«Ha fatto un brano, That That con Suga dei BTS, fichissimo! È stato numero uno in molte classifiche mondiali. Si tratta di un’operazione sicuramente studiata, comunque ha delle canzoni super orecchiabili, vedi Celeb».
Fabio, tu suoni, componi i tuoi brani?
«Non suono, ma ballo, canto e scrivo le mie canzoni. Poi mi faccio aiutare da un Producer coreano, perché sì, ascolto molto Kpop, ma non è sufficiente, devi affidarti comunque a loro».
Insomma, il Kpop è un fenomeno…
«È uno stile, in questo momento, quello più in voga al mondo, supervirale, grazie ai BTS. Quando ho scoperto il Kpop, dieci anni fa lo suonavano già in tutta Europa, tranne che in Italia dove è apparso da un paio d’anni. Mi ricordo le Girls’ Generation, si erano sciolte nel 2017 dopo dieci anni di attività…».

Curiosità: una volta sciolte le band, i singoli idol continuano la loro professione da solisti?
«È molto difficile che qualcuno rimanga. Secondo me perché, essendoci nel Kpop degli standard per quanto riguarda la costruzione di una band, il rapper, il solista, chi balla, chi fa i cori, nessuno nota i singoli in quanto tali. Vale il gruppo. Anche in Corea c’è la versione del cantante mascherato, quello di Raiuno. Capita molto spesso che l’artista, una volta tolto il travestimento, non venga riconosciuto. Tutti sanno che è un idol, per evitare imbarazzi viene subito annunciato il suo nome dal presentatore: questo è il tale, degli Winner…».
Conta il gruppo e non il singolo…
«Sono poche le band che hanno la fortuna di avere idoli riconoscibili, perché personaggi particolari. Una di queste sono i BTS!».
Fabio torniamo a te: quanti anni hai?
«Trentatrè. Di solito l’età standard per un artista di Kpop è 20 anni. Sono visto come un’anomalia qui. Sono straniero e sono anche una testa dura, insisto, devo riuscire a raggiungere i miei obiettivi. L’ho sempre fatto nella mia vita. Ho pensato: parlo numerose lingue asiatiche, sono esperto di Kpop, canto e scrivo in coreano perché non dovrei riuscirci? Quando ho iniziato a bussare alle porte della case discografiche, mi snobbavano. Mi vedevano attraente, ma quando leggevano la mia età si ritraevano. E io spiegavo loro: “guardate che canto, ballo, parlo le lingue asiatiche”. Ho dovuto insistere e quando alla fine sono stato preso dall’agenzia che mi sta preparando, mi hanno messo alla prova facendomi fare il colloquio in mandarino con un’interprete cinese. Alla fine hanno capito che non mentivo e mi hanno scritturato. Una soddisfazione. Ho realizzato pochi giorni fa il mio primo progetto, vediamo quando ci sarà l’uscita ufficiale…».
La tua idea è entrare in un gruppo Kpop?
«Mi intriga tantissimo. È un mio obiettivo, parallelamente alla mia carriera da solista. La mia intenzione è di unire il pop coreano a quello italiano. Mi piace sperimentare…».
In Corea come ti vedono?
«Non ho fatto ancora apparizioni in tivù».

Ma nelle Filippine sei diventato un idolo, hai fatto un gran bel successo…
«Sì, nel 2015, un successo pazzesco. Ho fatto un primo tour di circa tre mesi, poi un altro di quattro mesi. Sono stato invitato in radio, ho fatto apparizioni televisive e concerti. Qui in Corea sono venuto a cercare un’etichetta discografica e a prepararmi, a studiare. Perché altrimenti non si arriva in televisione. Per loro è inconcepibile che uno che canta non sappia anche ballare. Come reputano assurdo che in Italia nelle apparizioni televisive gli artisti possano cantare live. Qui non lo si fa quasi mai, perché tutto deve essere perfetto, nessuna sbavatura. È un’altra visione della musica pop».
Raccontami la tua giornata tipo.
«Mi alzo alle sei. Faccio un’ora di meditazione. Poi studio quattro ore di coreano. Quindi pranzo e subito dopo inizio, con gli insegnati, a fare due ore di preparazione vocale e altrettante di ballo, quindi studio da solo fino a tarda sera. Fosse per loro dovrei farlo 24 ore su 24! All’inizio non riuscivo a tenere questi ritmi, è tutta questione di allenamento».
Hai fatto un video musicale…
«Sono rimasti piacevolmente sorpresi, perché noi italiani siamo molto espressivi, parliamo anche con il corpo, cosa che qui non riescono a fare, perché non fa parte della loro cultura».
Fabio, com’è la vita in Corea? Che tipo di società è?
«Ti racconto sempre in base alla mia esperienza: sono arrivato durante il Covid, quindi immaginati tutte le restrizioni, loro sono generalmente rigidi, fiscali. È pur vero che ho vissuto il Paese in un periodo stressato, al limite. Mi sono innamorato di questo posto perché qui vedi il futuro. Vengo da Roma, una città splendida che amo, però quando sono arrivato a Seul ho percepito che c’è qualcosa di più. È un luogo colorato, un modo diverso di vivere la metropoli. I colori danno positività, energia, fascino. Per quanto riguarda la mia vita personale in Corea, l’ho trovata un po’ difficile. Noi italiani siamo abituati ad abbracciare, baciare, vabbè che c’era il Covid, ma ho percepito molto la distanza, loro sono più timidi, introversi rispetto a noi».
Sono un po’ freddi ma musica e ballo li fa scatenare…
«Chi fa un mestiere come il mio ha ritmi diversi, ma la gente normale è molto tranquilla, in metropolitana ci sono cartelli ovunque che dettano regole: non mangiare, non saltare, non chiacchierare rumorosamente. E tutti normalmente si attengono. Avverti che è un posto sicuro. Di contro, ciò porta a essere meno creativi, meno individualisti… non sono abituati a esprimersi veramente».
I tuoi cosa dicono della tua scelta?
«Ah beh, loro si sono abituati. Sono andato a vivere in Cina a vent’anni, sono avvezzi alle mie particolarità».
Cos’è per te la musica?
«Energia, vibrazioni, divertimento, movimento, suono che ti entra in testa e ti emoziona. È positività».
Ascolti altri generi oltre al Kpop?
«Sì, molto “altro” pop. Di quello italiano sono sempre stato un fan di Alexia, adoro la voce di Elisa, Mahmood, le follie di Blanco, i Måneskin, Laura Pausini secondo me è un genio. Tra le star internazionali, Taylor Swift a Beyoncé che è un cavallo da battaglia, un’artista fenomenale!».
Tornando agli Idol: nelle apparizioni televisive è tutto playback, ma quando suonano in concerto?
«È praticamente tutto live, riescono a farlo perché si dividono le esibizioni, quindi ballano e cantano tenendo un intero show. Poi c’è tutta un’energia diversa, coinvolgi il pubblico…».
E la musica è ovviamente live?
«Affatto. Quella è tutta registrata!».