 L’ultima novità che davvero si può definire tale del fine settimana appena trascorso proviene da un signore di 78 anni (il prossimo 24 maggio vedrà 79 primavere). Lui si chiama Bob Dylan, la canzone, Murder Most Foul. Nell’epoca dello speed reading, dello speed listening, dove meno parole e concetti sono più efficaci all’attenzione disattenta del nostro mordi e fuggi quotidiano, l’eterno menestrello del Minnesota ha deciso di far uscire – dopo un lungo periodo di raccolte e ripubblicazioni, l’ultimo disco in studio risale al 2012, ed è Tempest – un brano nuovo, original 100%, della durata di quasi 17 minuti. Una canzone che prende spunto da una frase shakespeariana, citata dal fantasma del re, padre, che appare ad Amleto per convincerlo del suo assassinio: «The Murder Most Foul, as in the best it is. But this most foul, strange and unnatural» – una morte disgustosa nel migliore dei casi, ma non solo, anche strana e innaturale.
L’ultima novità che davvero si può definire tale del fine settimana appena trascorso proviene da un signore di 78 anni (il prossimo 24 maggio vedrà 79 primavere). Lui si chiama Bob Dylan, la canzone, Murder Most Foul. Nell’epoca dello speed reading, dello speed listening, dove meno parole e concetti sono più efficaci all’attenzione disattenta del nostro mordi e fuggi quotidiano, l’eterno menestrello del Minnesota ha deciso di far uscire – dopo un lungo periodo di raccolte e ripubblicazioni, l’ultimo disco in studio risale al 2012, ed è Tempest – un brano nuovo, original 100%, della durata di quasi 17 minuti. Una canzone che prende spunto da una frase shakespeariana, citata dal fantasma del re, padre, che appare ad Amleto per convincerlo del suo assassinio: «The Murder Most Foul, as in the best it is. But this most foul, strange and unnatural» – una morte disgustosa nel migliore dei casi, ma non solo, anche strana e innaturale.
E, come successo ad Amleto, anche Dylan inizia a dipanare una lunga matassa di fatti, citazioni divagazioni, litanie per la sua Murder Most Foul, (iniziate ad ascoltarla mentre leggete queste righe) quella del presidente americano John Fitzgerald Kennedy, ucciso a Dallas il 22 novembre del 1963. Non ho capito perché proprio ora, in piena pandemia da coronavirus, non ho capito perché il saggio ed epico artista abbia sentito la necessità di fare questa lunga, appassionata digressione alla sua maniera su una pagina tremenda per gli Stati Uniti. Sembra un regalo ai suoi milioni di fan, ma anche un avvertimento. Sul suo sito ufficiale scrive poche righe di “presentazione” al suo nuovo brano:
«Greetings to my fans and followers with gratitude for all you support and loyalty across the years. This in an unreleased song we recorded awhile back that you might find interesting. Stay safe, stay observant and may God be with you»
Ci si può ricamare quello che si vuole, un inizio di addio, un inizio di qualcos’altro, magari un disco, o un passo necessario, arrivato alla sua età, per tentare di rimettere a posto il suo mondo secondo il suo credo. Comunque la si pensi, una volta messe le cuffie e sentito il profondo vibrato di un violoncello al quale si unisce il pianoforte e una sessione ritmica ridotta all’osso ma magicamente potente in un crescendo inesorabile, si rimane come ipnotizzati, come una delle sacre canzoni di Leonard Cohen o una di quelle cavalcate psichedeliche dei Genesis in grande spolvero.
Mano a mano che la trama si srotola partendo da quella morte “orribile”, ecco che si ape la sua America, quella che lui ha cantato e continua a cantare, acque apparentemente tranquille che improvvisamente si agitano, vorticano, creando dei mulinelli, archi che solcano le corde, tasti che pizzicano corde e corde le più profonde, che vibrano roche ed emozionali, sapienti chiaroscuri ammalianti che avvolgono il menestrello nella sua voce graffiante come il metallo del Minnesota, e negli intricati percorsi, epici viste anche le citazioni omeriche, di questi quasi 60 anni di storia americana. La voce assume quei toni gravi frutto degli anni, l’età glielo chiede e lui se lo impone. In questa lunga digressione di riferimenti (i suoi o quelli universalmente americani) inizia una lunga litania di autori, musicisti, poeti. Dylan ci indica così una colonna sonora di quasi un’ottantina di brani, e noi lì, col rosario in mano a sgranare e a ripetere a voce bassa i nomi, John Lee Hooker, Thelonius Monk, Charlie Parker, Nat King Cole…
Andrea Cossu, professore associato di Sociologia all’Università di Trento, e grande esperto dylaniano, nella sua bellissima e lunghissima recensione al brano pubblicata su gdm scrive: «Poche righe e Dylan ci porta in un viaggio (come Omero, come l’Odissea) in un terreno via via caratterizzato solo da note sparse, da versi che possono stare in un blues di Charlie Patton, in un falsetto di Clarence Ashley, in cui il mistero si fa via via più fitto e per questi motivi illuminante. Poche righe e “oggi è un buon giorno per morire”, nativi americani e Piccolo grande uomo. Poche righe e arrivano momenti cruenti che si possono cantare con la stessa musica di “Pay in Blood”, sempre da Tempest. Una serie di immagini che starebbero bene in “Narrow Way” dello stesso Dylan, o in “Killing Floor” di Howling Wolf. Perché “Murder Most Foul” è una broadside ballad ma anche un blues bastardo, e forse è anche un gospel, l’unica cosa possibile dopo il giorno del giudizio, quelle “36 hours past judgement day” che operano una cesura nella canzone…».
Ed eccoci dunque alla fine di questa inaspettata ventata firmata Bob Dylan. Una musica da quarantena? Può darsi. Una musica che fa riflettere, a prescindere, che ti aiuta, chiuso nel tuo studiolo di casa, o seduto sul divano a guardare il mondo là fuori che sembra passi tutto uguale, tutti seduti nelle nostre personali panchine solitarie. Un’opportunità per guardarci dentro, per essere schietti con noi stessi, su cosa siamo oggi e sui nostri piccoli Murder Most Foul che riponiamo dentro di noi senza avere il coraggio di gridarli al vento… Passerà, passerà, grazie anche a lui e alla musica.
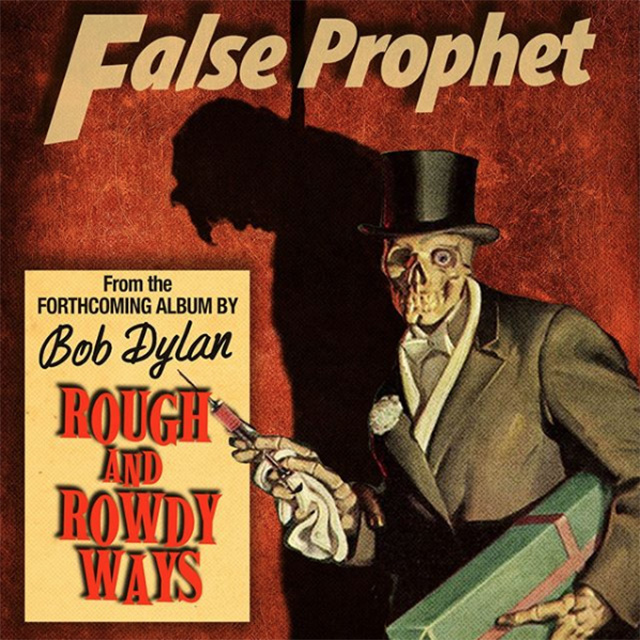



 L’ultima novità che davvero si può definire tale del fine settimana appena trascorso proviene da un signore di 78 anni (il prossimo 24 maggio vedrà 79 primavere). Lui si chiama Bob Dylan, la canzone, Murder Most Foul. Nell’epoca dello speed reading, dello speed listening, dove meno parole e concetti sono più efficaci all’attenzione disattenta del nostro mordi e fuggi quotidiano, l’eterno menestrello del Minnesota ha deciso di far uscire – dopo un lungo periodo di raccolte e ripubblicazioni, l’ultimo disco in studio risale al 2012, ed è Tempest – un brano nuovo, original 100%, della durata di quasi 17 minuti. Una canzone che prende spunto da una frase shakespeariana, citata dal fantasma del re, padre, che appare ad Amleto per convincerlo del suo assassinio: «The Murder Most Foul, as in the best it is. But this most foul, strange and unnatural» – una morte disgustosa nel migliore dei casi, ma non solo, anche strana e innaturale.
L’ultima novità che davvero si può definire tale del fine settimana appena trascorso proviene da un signore di 78 anni (il prossimo 24 maggio vedrà 79 primavere). Lui si chiama Bob Dylan, la canzone, Murder Most Foul. Nell’epoca dello speed reading, dello speed listening, dove meno parole e concetti sono più efficaci all’attenzione disattenta del nostro mordi e fuggi quotidiano, l’eterno menestrello del Minnesota ha deciso di far uscire – dopo un lungo periodo di raccolte e ripubblicazioni, l’ultimo disco in studio risale al 2012, ed è Tempest – un brano nuovo, original 100%, della durata di quasi 17 minuti. Una canzone che prende spunto da una frase shakespeariana, citata dal fantasma del re, padre, che appare ad Amleto per convincerlo del suo assassinio: «The Murder Most Foul, as in the best it is. But this most foul, strange and unnatural» – una morte disgustosa nel migliore dei casi, ma non solo, anche strana e innaturale.  Ci sono canzoni che sono entrate “sottilmente”, con grazia nel nostro quotidiano, al punto che sembra siano nate con noi. Esistono e basta, ce le portiamo avanti, spesso perdendone l’autore, tante sono le versioni che sono state incise e gli artisti che le hanno reinterpretate. Canzoni assolute, si potrebbe dire, canzoni senza tempo, che appartengono a tutti, alle emozioni di ciascuno di noi. Più o meno queste riflessioni mi son trovato a fare quando, martedì scorso, sulla mia solita tratta metropolitana diretto a Cadorna, è entrato uno dei tanti musicisti in cerca di moneta in cambio di una mini esibizione, sempre la stessa, di vagone in vagone. Violino, carrello della spesa riadattato a porta-amplificatore, sguardo assente, mezza età, elegante. C’erano pochi viaggiatori sul vagone… tempi magri con il coronavirus, protagonista assoluto delle nostre vite in questi strani giorni d’epidemia… Incuriosito, ho tolto le cuffie (stavo ascoltando Myopia, ultimo lavoro appena pubblicato della compositrice danese Agnes Obel, di cui vi parlerò – non prendetela come una minaccia!).
Ci sono canzoni che sono entrate “sottilmente”, con grazia nel nostro quotidiano, al punto che sembra siano nate con noi. Esistono e basta, ce le portiamo avanti, spesso perdendone l’autore, tante sono le versioni che sono state incise e gli artisti che le hanno reinterpretate. Canzoni assolute, si potrebbe dire, canzoni senza tempo, che appartengono a tutti, alle emozioni di ciascuno di noi. Più o meno queste riflessioni mi son trovato a fare quando, martedì scorso, sulla mia solita tratta metropolitana diretto a Cadorna, è entrato uno dei tanti musicisti in cerca di moneta in cambio di una mini esibizione, sempre la stessa, di vagone in vagone. Violino, carrello della spesa riadattato a porta-amplificatore, sguardo assente, mezza età, elegante. C’erano pochi viaggiatori sul vagone… tempi magri con il coronavirus, protagonista assoluto delle nostre vite in questi strani giorni d’epidemia… Incuriosito, ho tolto le cuffie (stavo ascoltando Myopia, ultimo lavoro appena pubblicato della compositrice danese Agnes Obel, di cui vi parlerò – non prendetela come una minaccia!).  Ed eccola lì:
Ed eccola lì: