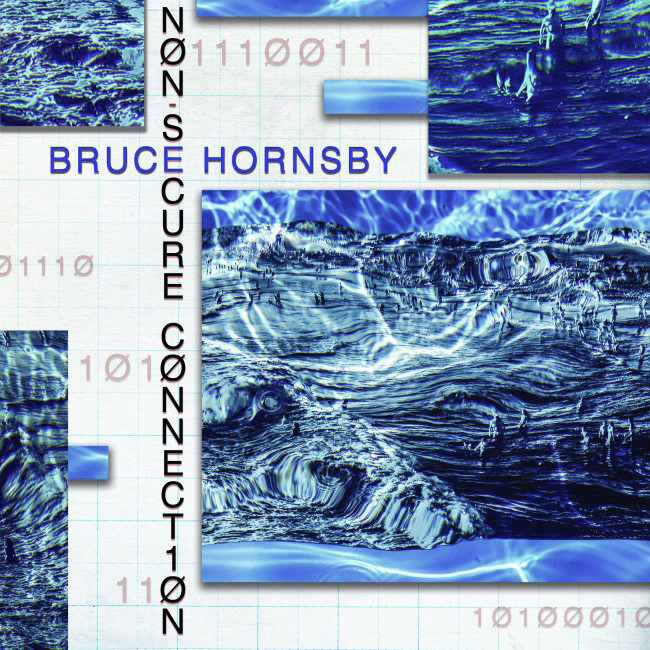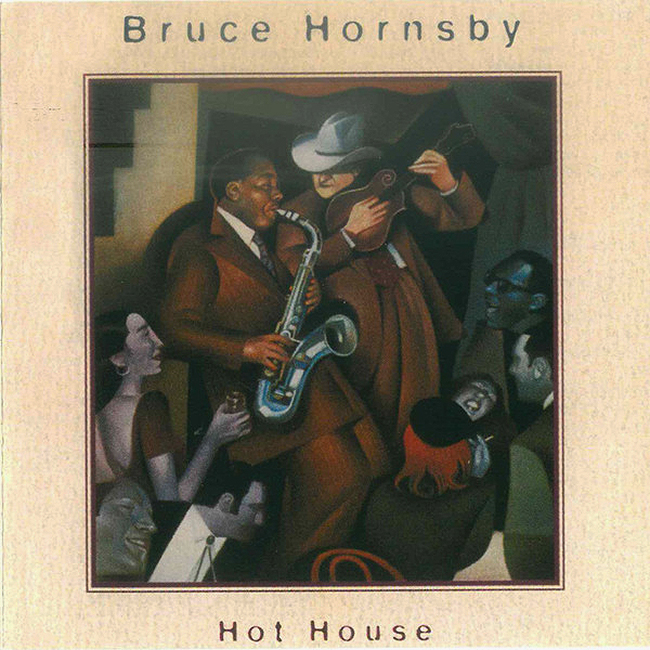Mi sto ascoltando l’album “espanso” Sign O’ The Times (Super Deluxe) uscito il 20 settembre scorso. Sign O’ The Times è forse – sicuramente per molti – il disco capolavoro di Prince, morto il 21 aprile 2016, uscito nel 1987. Un apparente intricato groviglio di generi, musiche, testi, partoriti dalla mente del mitico musicista di Minneapolis. Disordine creativo che aveva, eccome, un ordine, una serie di piani di lettura, a ben ascoltare, che si intersecano e si espandono in altri orizzonti. Insomma, una specie di matrioska del pentagramma. Qualcuno, ai tempi, l’aveva definito uno spartiacque per la musica afroamericana e per la sua stessa carriera. «L’ultimo grande album R&B prima che l’hip hop diventasse la forma dominante della musica pop dell’America nera» (Michaelangelo Matos dal libro Sign O’ The Times publicato per Bloomsbury nel 2004).
La nuova versione di Sign O’ The Times conta 92 brani, tutti scritti e suonati dallo stesso Prince, senza i Revolution, esperienza finita più o meno in quel periodo. Una raccolta “confezionata” da Michael Howe, responsabile dello sterminato archivio di Prince, in collaborazione con la Prince Estate e la casa discografica (NPG Records su licenza Warner Records). Una rilettura di pubblica utilità, si potrebbe dire, del genio strabordante di Prince. E fin qui tutto ok. Raccolta iperinteressante, avvincente per molti versi.

Ma… Sì, c’è un ma, uno scrupolo di coscienza, potrei definirlo. Che genera una domanda: è giusto sfruttare inediti di un artista che non c’è più? Non è una violazione della sua intimità, della sua scelta di tenere da parte brani che, forse, dovevano/potevano servire ad altro nelle sue intenzioni?
È vero, i fan ringraziano, hanno ricevuto dell’ottimo cibo stellato da degustare, ma quanta memoria abbiamo violato per arrivare a ciò? Della difesa strenua della sua musica Prince ne ha fatto un cavallo di più battaglie, contro le case discografiche (vedi la Warner), gli streaming (bussa a Spotify) o i filmati non autorizzati (rivolgersi a YouTube).
Ora, probabilmente per mettere a frutto il patrimonio da dividere tra gli eredi, si incrementa il flusso di denaro grazie a Prince che è cenere. La Prince Estate ringrazia e con lei la casa discografica. Così era successo, ed è storia, a Jimi Hendrix, con le uscite postume di album che ne hanno sì, aumentato la leggenda, ma che suonavano tanto di “abuso di cadavere”.
Davvero, non so se sia giusto o meno sfruttare il patrimonio artistico di musicisti del calibro di Prince, o di Jimi, o di 2Pac… E non prendetemi per uno dei tanti “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Sento solo un senso di disagio nell’ascoltare brani che sembrano “violati” dal silenzio perenne di una persona che non esiste più. Il mito va saziato per rimanere tale. Passi. È il costo etico di questa operazione che mi lascia perplesso. Probabilmente son fatto male io.